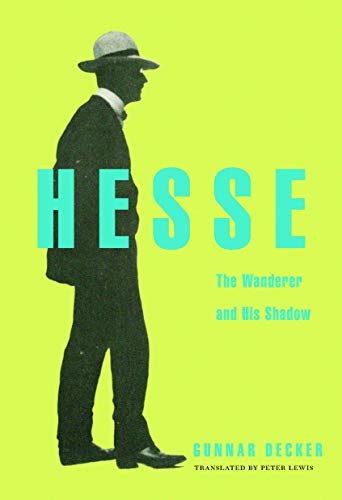
“Ora come ora non c’è nessun vantaggio nell’essere un lettore di Hesse”.
Questo mesto giudizio sullo scrittore Herman Hesse, riportato nelle pagine d’apertura della nuova biografia firmata Gunnar Decker, “Hesse: The Wanderer and His Shadow” (Harvard), apparve per la prima volta in un necrologio del 1962, ma potrebbe essere stato scritto ieri oppure cento anni fa.
Fin dalla sua prima pubblicazione, nel 1904, Hesse si è configurato come uno di quegli strani scrittori che riescono ad essere contemporaneamente dei canoni – grazie al Premio Nobel per la letteratura nel 1946 – e costantemente invisi ai critici.
I grandi “modernisti” tedeschi, suoi contemporanei, di fatto lo disprezzarono: “un uomo modesto”, per il poeta Gottfried Benn;
“dimostra di avere manie tipiche di uno scrittore molto più grande di quanto non sia mai stato” ne disse Robert Musil.
Ancora oggi, in America, Hesse viene considerato dall’élite come uno scrittore per adolescenti. Amarlo è visto come un buon segno a quindici anni, ma diventa cattivo a venti.
Per molti lettori, i romanzi di Hesse sono le prime opere di narrativa seria a essere lette – il lasciapassare per una dipendenza letteraria. Questo accadde soprattutto negli anni Sessanta, quando la moda di Hesse si diffuse a livello internazionale e i suoi libri divennero la porta di entrata per la controcultura: Timothy Leary consigliava
“prima di farvi la vostra dose di LSD, leggete Siddhartha e Il lupo della steppa”.
Va tuttavia detto che gli adolescenti erano diventati i lettori tradizionali di Hesse molto tempo prima, cosa che talvolta irritava lo stesso autore. Il suo primo romanzo – Peter Camenzind, la storia di un ragazzo capriccioso e amante della natura che decide di abbandonare la società borghese – venne adottato come modello dai Wandervogel, un movimento giovanile di ritorno alla natura che promuoveva quello che lo stesso Hesse derideva come “romanticismo da falò”.
“Prendere Peter come modello per le masse significa aver frainteso totalmente il senso del personaggio” si lamentò Hesse, che “non intendeva percorrere il cammino già tracciato dagli altri, ma scavare il suo stesso sentiero … non era fatto per la vita collettiva”.
Se non altro, questo libro era stato scritto da un giovane autore sui problemi dei giovani. Lo stesso però non può essere detto per Il lupo della steppa, che invece narra della crisi di mezza età di un intellettuale. Non occorre certo guardare alle iniziali di Harry Haller, il triste eroe del libro, per vedere nel protagonista il riflesso dello stesso scrittore, ormai giunto ad un’età avanzata. Strano pensare che un’opera come questa possa essere diventata la bibbia degli anni Sessanta, fino ad ispirare il nome della band autrice di Born to Be Wild. Hesse non visse abbastanza per sapere come gli anni Sessanta avrebbero trasformato la sua figura; tuttavia aveva visto in precedenza questi processi che rendevano cult un certo personaggio e non gli erano piaciuti. “Spesso trovavo fastidiosi i ragazzini che a scuola leggevano e si entusiasmavano per le pagine de Il lupo della steppa”, scrisse nel 1955. “Dopotutto avevo scritto quel libro appena prima del mio cinquantesimo compleanno”.
Ciononostante, i giovani lettori di Hesse, oggi come allora, non erano completamente nel torto quando pensavano che quelle opere fossero state scritte per loro. Queste storie piacevano ai giovani, perché promuovevano le potenti emozioni dell’adolescenza, spesso dimenticate o rigettate dagli adulti – il sentirsi feriti, l’esaltazione, le enormi aspettative nei confronti della vita. Il giovane Emil Sinclair, voce narrante di Demian, rappresenta un buon esempio della tendenza di Hesse a prendersi troppo sul serio.
“Sono stato e sono tuttora una persona con molte domande, ma ho smesso di cercare risposte nelle stelle e nei libri. Ho iniziato a prestare attenzione agli insegnamenti sussurrati dal mio stesso sangue. La mia storia non è una storia divertente; non è né dolce né armoniosa, come invece lo sono di solito le storie inventate. Ha il sapore dell’insensato, della pazzia e dei sogni – come del resto le vite di tutti gli uomini che smettono di illudersi”.
In realtà, molti giovani videro nell’eroe tipico di Hesse un riflesso glamour di se stessi – uomini sensibili e cupi che non riescono a trovare il loro ruolo nella società. Tale eroe potrebbe aver vissuto in India, all’epoca del Buddha, come Siddhartha, o in Germania all’età del jazz, come Harry Haller, oppure nel Medioevo, come Boccadoro in Narciso e Boccadoro. Al di là del luogo e del tempo della narrazione, il percorso di questi personaggi attraverserà più o meno le stesse tappe. Sarebbero stati strappati via dal mondo dell’infanzia e mandato in una scuola di élite dove avrebbe sofferto terribilmente; si sarebbe ribellato contro un’idea conformista di successo, rifiutandosi di intraprendere qualsiasi tipo di carriera, combinando una discesa sociale con una profonda crisi spirituale. Spesso, proprio come accade per Peter Camenzind, avrebbe iniziato a bere e avrebbe finito col considerare l’alcolismo come una specie di nobile infermità.
“Il dio del vino mi ama e mi spinge a bere solo quando il suo spirito e il mio entrano in profondo contatto”, sostiene Peter.
Proprio perché l’eroe di Hesse svolge un ruolo precario nella società, egli è caratterizzato da un’estrema arroganza – Siddhartha chiama le persone attorno a lui “bambini” – e da un forte disprezzo di se stessi. Non c’è da stupirsi allora che lo stesso autore abbia, che li abbia poi messi in atto o meno. Infatti, come Hesse scrive ne Il lupo della steppa
“È sbagliato chiamare suicidi soltanto coloro che si autodistruggono … Ciò che caratterizza il suicida è che il suo ego, a torto o a ragione, si considera come un germe pericoloso, sinistro e maledetto per la natura circostante; si sente come se fosse costantemente esposto ad uno incredibile rischio”.
Il sentimento che la propria vita interiore sia pericolosa e rischiosa è qualcosa che perdiamo con il tempo – in parte perché con l’età diventiamo più calmi, in parte perché finiamo per riconoscere la reale natura delle persone. Tuttavia gli eroi di Hesse sono degli irrecuperabili Peter Pan – non crescono e disprezzano coloro che invece lo fanno, in quanto per loro crescere significa arrendersi al conformismo e alla comodità borghese. […] In altre parole, la maggior parte delle persone sono “phonies”, termine usato da Holden Caulfield, un altro modello preferito dai lettori adolescenti. Ciò che tormenta Hesse è la difficoltà di essere autentici – rimanere fedeli a ciò che si è veramente, nonostante l’enorme pressione esercitata dal conformismo e dai processi di alienazione. “Se guardo retrospettivamente alla mia opera per cercare un filo rosso, posso in effetti trovare un tema ricorrente”, scrisse Hesse poco prima di morire. Questo leitmotiv è “una difesa (talvolta disperata) della natura umana, dell’individualità”.
La biografia di Decker mostra proprio come la vita di Hesse coincise con un difficile compromesso tra il suo assolutismo spirituale, che lo spinse sempre ad un’irascibile voglia di isolarsi, e i suoi bisogni di essere umano, che, d’altro canto, lo portarono ad avere intorno a sé mogli, figli e case, che però non riuscì mai ad accettare completamente come parte importante della sua esistenza. Sposato per ben tre volte non fu mai un marito o un padre felice, e in effetti nella maggior parte delle sue opere i protagonisti evitano di ricoprire tali ruoli. Il suo ultimo romanzo, Il giuoco delle perle di vetro, tratta di una specie di fantasia futuristica su un’accademia i cui membri erano tutti privi di una famiglia.
Non c’è da stupirsi se l’autore Hesse rimase legato al mondo dell’adolescenza, in quanto proprio i suoi anni da giovanili, cioè gli anni Novanta dell’Ottocento, furono per lui i più importanti, ma anche i più drammatici. Fu proprio in questo periodo che realizzò il peso della pressione esercitata su di lui dalle istituzioni sociali – la chiesa, la scuola, la società – e con esse si scontrò al fine di difendere la propria individualità. Vinse, ma non senza riportare profonde ferite; in un certo senso le sue opere sono una rimessa in atto di questa lotta primordiale.
Fin dalla sua più tenera età fu chiaro che tra Hesse e la sua famiglia esisteva un profondo divario. Era nato nel 1877, a Calw, un piccola cittadina della Foresta Nera, nella Germania sud-occidentale, dove suo padre e suo nonno lavoravano insieme in una tipografia cristiana. Egli discendeva, sia dal lato materno che da quello paterno, da seguaci devoti del pietismo, una setta del protestantesimo tedesco che, come il metodismo in Inghilterra, non riconosceva la Chiesa ufficiale e urgeva i credenti ad una lotta disperata, fervente ed evangelica per trovare la virtù. Come scrive Decker, il pietismo “considerava come discendente dal diavolo tutto ciò che non avesse lo scopo primario di preparare l’anima per il regno di dio, per l’aldilà”. Per quanto riguarda la crescita di un bambino, questa convinzione venne a coincidere, almeno in casa Hesse, con un tenace e concertato sforzo finalizzato a piegare la volontà del giovane Hermann, per insegnargli ad essere docile e sottomesso, così come comandato da Dio. Tuttavia, in Hermann questa lotta religiosa incontrò un’irremovibile opposizione.
“Ero figlio di genitori pii, che ho amato profondamente, e che avrei amato ancora di più se non mi avessero ripetuto il quarto comandamento così assiduamente fin dai primi anni della mia vita. Purtroppo, i comandamenti hanno sempre avuto un effetto catastrofico su di me”, ricorda Hesse un un bozzetto autobiografico.
Rifiutò l’imposizione che lo obbligava ad amare suo padre e sua madre. Nel suo diario, la madre di Hesse narra di un incidente in cui un Hermann di tre anni si mise una lama di ferro in bocca e, quando gli dissero che ingerendola sarebbe potuto morire, testardamente replicò: “Non mi importa! Se muoio e finisco sotto terra, basta che mi possa portare qualche libro illustrato con me”. Qualche anno più tardi, il padre prese in considerazione l’idea di mandarlo via di casa “in un istituto o in un’altra famiglia affinché lo possa allevare”. Dal canto suo, Hesse si ricordava che, quando era bambino, sognava di dare alle fiamme la sua casa e di uccidere suo padre.
Queste tensioni esplosero nel 1891, quando Hesse fu ammesso a Maulbronn all’età di 14 anni: una scuola di élite ospitata in un un’abbazia medioevale. La missione di questo istituto era di reclutare i ragazzi più brillanti della regione e trasformali in ministri del culto luterano. Per poter entrare in questa scuola si doveva superare un esame molto impegnativo, esperienza che marcò Hesse così profondamente che la riportò in diverse sue opere. In effetti molte di esse non sono solo romanzi di formazione – il Bildungsroman assurto al ruolo di classico della letteratura tedesca fin dai tempi di Goethe –, quanto piuttosto di istruzione scolastica. Ogni dormitorio a Maulbronn, per esempio, portava un nome altisonante; Hesse viveva in quello di Hellas, un tributo all’idolatria che le scuole convenzionalmente riservavano al mondo greco. Quindici anni dopo, quando si trattò di romanzare queste vicende in Sotto la ruota, Hesse narra di un ragazzo che frenatava una scuola simile a quella di Maulbronn, alloggiato in un dormitorio chiamato proprio Hellas. In maniera analoga, trentasette anni dopo, ne Il giuoco delle perle di vetro, si leggerà la storia di Joseph Knecht, anche lui studente alloggiato in un dormitorio che porta il medesimo nome.
In Sotto la ruota, molte delle esperienze di Hesse vengono riflesse nella storia di Hans Giebenrath, un ragazzo talentuoso distrutto dallo studio, mentre tenta di entrare in un istituto di élite proprio come la suola di Maulbronn. Alla fine riesce a superare l’esame di ammissione, dopo aver sgobbato così duramente che tutta la giovanile voglia di vivere che lo contraddistingueva sparisce. Presto viene sopraffatto dalla disperazione e dall’apatia e così l’unica soluzione sarà quella di lasciar perdere tutto; alla fine morirà affogato, probabilmente un suicidio. La conclusione riflette molto dell’autocommiserazione sentita dallo stesso autore: “ha provato tutti i sentimenti della nausea, della vergogna e della sofferenza; ormai la fredda e bluastra notte di autunno getta lo sguardo sulla sagoma nera del suo corpo alla deriva e la torbida acqua gioca con le sue mani e con i suoi capelli e con le sue labbra esangui” […].
Hesse riuscì ad evitare il destino di Hans Giebenrath, ma solo a stento. Nel marzo del 1892, scappò da Maulbronn e venne dato per disperso. Ritornò solo dopo un giorno e, come scrive Decker, questa sua assenza ingiustificata venne considerata come un crimine inimmaginabile per un ragazzo di quattordici anni. La reazione della scuola e della famiglia fu estrema, rispecchiando appieno la concezione religiosa dei suoi genitori. Infatti, appena saputo della sua scomparsa, la madre sperò che fosse morto: “Ero davvero molto sollevata dopo aver saputo che finalmente … era stato preso dalle mani piene di misericordia di Dio”, tali le parole riportate nel suo diario.
Purtroppo Hermann tornò a casa sano e salvo e questo fu un bel problema. Dovette lasciare la scuola e i suoi genitori, incapaci di comunicare con lui, pensarono di farlo ricoverare in un ospedale per igiene mentale. Confrontatosi con la prospettiva di una prigionia a tempo indeterminato, Hesse iniziò a bombardare i genitori con strazianti lettere: “odio tutto qui dal profondo del mio cuore. Sembra che sia stato creato solo per dimostrare ad un giovane ragazzo quanto sia maledetta la vita in ogni suo aspetto”.
Dopo molti mesi, Hesse ottenne un periodo di prova nel quale venne liberato e potè frequentare una scuola superiore locale. Tuttavia la spaccatura nel rapporto con i suoi genitori rimase permanente: quando sua madre morì nel 1902, si rifiutò di partecipare al funerale. E il danno alla sua carriera sembrò anch’esso irrecuperabile. A Maulbronn, si trovava su una corsia preferenziale che lo avrebbe tranquillamente portato a diventare un ministro del culto o un insegnante. Adesso però l’università era fuori questione e Hesse iniziò un apprendistato presso un librario. Per i suoi genitori – e sicuramente anche per se stesso – doveva aver preso ormai la strada del fallimento.
Ma il genio di Hesse era in procinto di abbracciare questo fallimento per renderlo una fonte di ispirazione. “In principio era il mito”, è la prima frase del Peter Camenzind, l’opera che salvò Hesse dall’oscurità e dalla povertà; e in molti dei suoi libri racconta ancora e ancora lo stesso mito, che Hesse pensò di interpretare per tutta la vita. In effetti, i libri di Hesse possono essere compresi al meglio se li si analizza come le versioni successive di un’autobiografia spirituale – ironico pensare che questo tipo di opere costituivano un canone nella letteratura religiosa interna al pietismo. “L’unico modo in cui io possa pensare di scrivere”, disse una volta Hesse “è come una forma artistica di confessione” – una considerazione che avrebbe potuto essere tranquillamente appoggiata dal nonno paterno, un dottore che alla sua morte lasciò un diario in due volumi. In effetti, pur ribellandosi alle sue radici pietiste, Hesse finì per abbracciare i temi che caratterizzano questa corrente religiosa: non perse mai l’abitudine ad una rigorosa introspezione, non mancò di provare sentimenti di disprezzo verso se stesso e di ricercare un’esperienza di vicinanza con il divino.
La vera differenza è che lui non riuscì mai a concepire l’idea di provare questo tipo di esperienza in seno alla corrente del pietismo. “Se fossi cresciuto nell’ambito di un tradizione religiosa rispettabile, per esempio come cattolico, probabilmente non ne sarei mai uscito”, spiegò con disappunto. Al contrario, sentì la necessità di colmare il suo bisogno di spiritualità guardando ad altre tradizioni e finendo per ammirare figure inclini a sfidare il dogma e la dottrina. Francesco d’Assisi fu una prima figura ispiratrice: Hesse scrisse una breve biografia del santo che predicava agli animali e chiamava il sole e la luna come fratello e sorella.
Presto iniziò a cercare più lontano – specialmente in Oriente, nelle tradizioni religiose dell’India. Anche questo si configura in realtà come un ritorno alle origini – il nonno materno, in qualità di missionario, aveva trascorso molti anni in India, e sua madre era cresciuta lì per un certo periodo. Tuttavia, mentre loro si trovavano lì per diffondere una religione, quella cristiana, che ritenevano essere l’unica giusta, Hesse andò in questo paese come un ricercatore curioso. Nel 1911 intraprese un viaggio verso Ceylon e Singapore, che però all’epoca fu motivo di grande delusione – non riuscì ad abituarsi al clima – ma gettò le fondamenta per l’opera successiva Il pellegrinaggio in Oriente, dove egli immagina una società segreta di natura spirituale in cui si riuniscono le grandi menti di Europa e Asia.
Il libro che, per la maggior parte dei lettori, collega maggiormente la figura dello scrittore tedesco con l’india è Siddhartha. Pubblicato nel 1922, agli albori di quella Prima Guerra Mondiale che avrebbe distrutto e smembrato la società europea, Siddhartha permette al lettore di rifugiarsi lontano nel tempo e nello spazio – l’India del Buddha, quinto secolo prima di Cristo. In questo breve libro, Hesse riconduce l’archetipo narrativo al suo cuore mitologico più profondo. Ancora una volta incontriamo un un giovane ragazzo, sensibile e dotato – Siddhartha, il figlio di un bramino – che respinge la sua famiglia, la sua religione e le sue aspirazioni, per ritrovare se stesso e la sua vera natura.
Lungo il suo percorso, soffrirà la privazione, come un asceta o come un eremita errante, ma anche l’opulenza, in qualità di amante ricco della cortigiana Kamala. Eppure rimarrà sempre insoddisfatto in tutte le circostanze, finché non si renderà conto che la vera saggezza corrisponde al distacco, alla pacifica rassegnazione a qualsiasi evento possa accadere. La vita non può essere fermata o bloccata in uno spazio, ma scorre come il fiume presso le cui sponde Siddhartha riceve la rivelazione […].
Siddharta è un’opera volta alla saggezza – un insegnamento. Tuttavia il messaggio più importante consiste nell’impossibilità di imparare qualsiasi cosa che un guru o un insegnante vorrebbe insegnare. La rivelazione di Siddhartha ha un approccio molto buddista e Hesse prese in prestito il nome del protagonista proprio da Siddhartha Gautama, il fondatore del buddismo. Ciò nonostante, nel capitolo più importante di tutto il libro, Siddhartha effettivamente incontra il Buddha, ma poi se ne allontana. D’altro canto, il suo amico Govinda, più timido e conformista, diventa un monaco buddista, Siddhartha sa che ogni tipo di religione – anche la più vera e ammirevole – costituisce un ostacolo alla rivelazione.
“Nessuno arriverà alla redenzione attraverso la dottrina!” esclama. Dopotutto, Buddha non divenne il Buddha seguendo il Buddha, ma creando il proprio cammino. La morale di Hesse è simile a quella ritratta in un famoso proverbio Zen: “Se incontri il Buddha sulla tua strada, uccidilo”.
L’importanza data da Hesse all’auto-determinazione, che riecheggia gli insegnamenti di Emerson – altro scrittore affascinato dalle religioni orientali – lo aiutò a diventare una guida sicura per una generazione di lettori la cui fiducia nelle istituzioni sociali era stata distrutta dalla Prima Guerra Mondiale. In effetti, la celebrità di Hesse come scrittore saggio fu determinata sopratutto tramite le opere che scrisse dopo la Guerra – iniziando con Demian, nel 1919, e proseguendo con Siddhartha e Il lupo della steppa, negli anni Venti.
Pur essendo tedesco, Hesse risiedette in Svizzera – visse lì a più riprese nei primi anni della sua vita e poi in maniera permanente dal 1912 – e osservò la febbre bellica che invase la Germania da una posizione distaccata. (Ciò nonostante fece richiesta di entrare come volontario nell’esercito tedesco, che però venne rifiutata a causa della sua scarsa vista, risultata da un incidente giovanile con i fuochi di artificio). Nel primo periodo della Guerra, Hesse pubblicò un pamphlet nel quale, pur sperando in una vittoria della Germania, sottolineava l’importanza di perpetuare i valori di umanità e di cooperazione tra le nazioni. “Questa disastrosa guerra mondiale deve servire ad inculcarci ancora più fermamente la convinzione che l’amore è meglio dell’odio”, scrisse. Pur scrivendo in toni pacati e concilianti, con questo scritto si guadagnò l’ostilità permanente di molti tedeschi. Per il resto della vita fu attaccato dalle frange nazionaliste sia sulla stampa sia tramite lettere cariche d’odio.
Per questa ragione, negli anni Trenta, la sua ostilità nei confronti di Hitler fu automatica. Il nazismo con la sua dottrina di sacrificio dell’individuo ai fini della salvezza dello stato e della razza, rappresentava l’opposto di tutti i suoi ideali. Nel marzo del 1933, sette settimane dopo la salita al potere di Hitler, Hesse scrisse ad un suo corrispondete tedesco: “è un dovere morale stare chiusi in se stessi e di non cantare in coro con coloro che sciorinano a squarciagola le canzoni patriottiche che i loro leader gli hanno imposto di cantare”.
Tuttavia, pur aiutando e ospitando tantissimi scrittori emigrati – tra cui il caro amico Thomas Mann – Hesse non si spinse mai in una vera e propria politica anti-nazista. Decker mostra come, negli anni Trenta, fece un timido atto di resistenza, recensendo e pubblicizzando le opere di autori ebrei tedeschi. Tuttavia, è rivelatore il fatto che i suoi libri non vennero banditi dai nazisti fino al 1943.
Fu Thomas Mann che, alla fine della Prima Guerra Mondiale, pubblicò un libro dal titolo Considerazioni di un impolitico; tuttavia il ruolo di impolitico calzerebbe a pennello più a Hesse, per il quale essere lontano dalla politica era uno dei principi fondamentali. Dopotutto se il mondo e anche noi essere umani non siamo altro che illusioni, è inutile credere che si possano redimere. A coloro che gli chiedevano di prendere una posizione pubblica più decisa contro Hitler, Hesse replicò che l’antifascismo era un tradimento dell’individuo tanto quanto lo era il fascismo: “Che c’entra con me ?”, chiese. “Io non posso cambiare nulla. Tuttavia, ciò che posso fare, è offrire un po’ di aiuto a coloro che, come me, lottano per fare qualsiasi cosa conto il potere e la supremazia”.
Questa attitudine nei confronti della politica e della Storia è tipica di quello che Hegel chiamava “l’anima bella” – colui che rimane lontano dal mondo perché non vuole averci niente a che fare. L’espressione fu inventata da Goethe, che la usò nella sua opera Riflessioni di un’anima bella (sesto volume delle Esperienze di Wilhelm Meister n.d.t), un’opera narrativa in cui una nobildonna pietista descrive la sua vita spirituale. Hesse, per analogia, potrebbe essere definito come un’“anima brutta”, colui che è così occupato con i suoi problemi spirituali da non curarsi del mondo circostante. Questa è anche la chiave per capire il fascino esercitato dall’opera di Hesse nei confronti dei lettori più giovani, che raramente vedono oltre il proprio io. Tuttavia la completa carenza tematica di Hesse è ciò che garantirà la vita ai suoi scritti. Finché l’uomo continuerà a lottare per riuscire ad essere se stesso, e patirà le difficoltà derivanti da ciò, rimarrà una presenza letteraria costante – il che è, forse, meglio che essere un grande scrittore.
Questo post è frutto di una libera traduzione dell’articolo “Hermann Hesse’s Arrested Development” apparso su The New Yorker il 19 novembre 2018. Questo è il link all’articolo in lingua originale: https://www.newyorker.com/magazine/2018/11/19/hermann-hesses-arrested-development Tutti i diritti sono riservati all’autore ©Adam Kirsh

L’ha ribloggato su l'eta' della innocenza.
"Mi piace"Piace a 1 persona