O quando tutte le notti – per pigrizia, per avarizia – ritornavo a sognare lo stesso sogno: una strada color cenere, piatta, che scorre con andamento di fiume fra due muri più alti della statura di un uomo; poi si rompe, strapiomba sul vuoto. Qui sporgendomi da una balconata di tufo, non trapela rumore o barlume, ma mi sorprende un ribrezzo di pozzo, e con esso l’estasi che solo un irrisorio pedaggio rimanga a separarmi… Da che? Non mi stancavo di domandarmelo, senza però che bastasse l’impazienza a svegliarmi; bensì in uno stato di sdoppiata vitalità, sempre più retratto entro le materne mucose delle lenzuola, e non per questo meno slegato ed elastico, cominciavo a calarmi di grotta in grotta, avendo per appiglio nient’altro che viluppi di malerba e schegge, fino al fondo dell’imbuto, dove, fra macerie di latomia, confusamente crescevano alberi (degli alberi non riuscivo a sognare che i nomi, ho imparato solo più tardi a incorporare nei nomi le forme).
Gesualdo Bufalino, Diceria dell’untore, Sellerio, 1981
Si apre con un sogno «Diceria dell’untore», primo romanzo di Gesualdo Bufalino e premio Campiello 1981. È l’incipit tipico di un romanzo non realista, di una narrazione filtrata dalla coscienza e dagli sparsi ricordi – “barlumi” – del protagonista-narratore: un libro comunque autobiografico, visto che l’autore fu veramente ricoverato in un sanatorio vicino Palermo nell’immediato dopoguerra (l’azione si svolge nel 1946). La Rocca è un luogo di reclusione per degenti che cercano strenuamente di sopravvivere alla tubercolosi, ben sapendo che tutto sarà probabilmente inutile: un’attesa della morte che è anche apprendistato, una lezione di cui l’io narrante, salvandosi, ha fatto tesoro e che lo ha spinto a scrivere il testo. Ci racconta la vita degli altri pazienti e la sua, il suo rapporto antagonistico con il primario, chiamato il Gran Magro. Ai grandi temi della malattia e della morte si accompagna la problematica religiosa (Dio, gigantesco eufemismo) introdotta dalla vicenda di padre Vittorio, frate che nell’imminenza della morte sente vacillare e venir meno la propria fede, finché un’altra malata, l’ex ballerina Marta, avrà una relazione con il protagonista, introducendo nel racconto il tema amoroso. Non è una novità il connubio Amore-Morte, non davvero, ma l’autore riesce a renderlo originale grazie alla sua tecnica narrativa e, come si vedrà, alla ricchezza espressiva della sua parola. A quel luogo sospeso che è la Rocca, deputato alla malattia e alla morte, si contrappone l’esterno, con le vie, le piazze e gli alberghi visitati dai due amanti, luoghi che segnano la loro temporanea reviviscenza (e la salute per lui, mentre lei morirà in circostanze tragiche). Marta, in realtà un’ebrea scampata a un lager nazista, ha un passato terribile, di cui si intravedono solo alcuni tratti, e non è una figura cristallina, tutt’altro (la tisi è il contrappasso delle sue “felici colpe”); come personaggio assolve la funzione di catalizzare le passioni non solo del protagonista, ma anche del Gran Magro, suo rivale in amore, ma ha la dignità del grande personaggio. La fine di padre Vittorio e di altri ricoverati, di Marta e poi quella del Gran Magro conclude praticamente la mesta vicenda. Il protagonista l’ha rievocata nell’anno 1971: Oh sì, furono giorni infelici, i più felici della mia vita.
La presentazione del romanzo qui abbozzata, ad opera di una delle tre coordinatrici del «Caffè letterario di Zurigo», si è conclusa con l’elogio della lingua letteraria bufaliniana, con i suoi virtuosismi stilistici, la densità semantica delle parole, le acrobazie lessicali, l’innovativo linguaggio figurato, le volute sintattiche complesse, l’ironia. Ricerca barocca, forse, ma intrisa di lirismo e tale da rappresentare il gioco e il teatro in cui consiste essenzialmente, secondo l’autore, la vita guardata dal lato dell’individuo e in chiave antropologica. La cifra stilistica di Bufalino riflette la sua visione dell’esistenza e non è mai gratuita perché essenziale alla sua poetica.

Dopo quest’ampia introduzione si è passati alla discussione (dall’andamento un po’ disordinato), che ha rivelato tra i numerosi presenti (almeno venticinque) sia estimatori che critici più o meno severi.
Il tema centrale del testo è stato ritenuto interessante praticamente da tutti, ma qualcuno ha trovato la narrazione poco fluida a causa della ricercatezza della lingua, che caratterizza persino i dialoghi dei personaggi popolari. Ma si tratta di un libro di ricordi, si è risposto, e le parole degli altri, filtrate dalla memoria, non possono essere enunciate se non tramite quelle di chi ricorda. Del resto, dialoghi neorealisti non potrebbero apparire in un libro che è stato scritto e lasciato in un cassetto dall’autore per circa trent’anni, in attesa che la stagione neorealista terminasse. Uno dei lettori del gruppo, anch’egli scrittore, ha frequentato Bufalino e ha raccontato qualche aneddoto. Notato da Sciascia per la prefazione scritta a una raccolta di fotografie, fu da lui raccomandato per la pubblicazione alla Sellerio; il libro divenne subito un best-seller. Così si espresse Bufalino in un’intervista all’Espresso del 1° marzo 1981:
L’ho pensato e abbozzato verso il ‘50, l’ho scritto nel ‘71. Da allora una revisione ininterrotta: fino alle bozze di stampa. Mi è venuto dall’esperienza di malato in un sanatorio palermitano: negli anni del dopoguerra, quando la tubercolosi uccideva e segnava ancora come nell’Ottocento. Il sentimento della morte, la svalutazione della vita e della storia, la guarigione sentita come colpa e diserzione, il sanatorio come luogo di salvaguardia e d’incantesimo (ma La montagna incantata, è evidente, non ha giocato per nulla). E poi la dimensione religiosa della vita, il riconoscersi invincibilmente cristiano. M’importava esorcizzare quell’esperienza; ma soprattutto mi urgeva coagulare eventi e persone intorno a un centro di parole che avevo dentro. […]
(In http://www.italialibri.net/opere/diceriadelluntore.html)
Alcuni hanno criticato la struttura del testo, che mostra una trama fin troppo esile, ma quest’ultima citazione, richiamata nella discussione, dimostra come l’interesse dell’autore si concentrasse soprattutto sul «centro di parole» che aveva dentro, non sulla trama. Semmai sono da notare ne l testo le fitte corrispondenze interne, rimandi che guidano il lettore alla scoperta dei significati più ricorrenti. L’autore ha voluto esorcizzare la sua esperienza di malattia e di contatto con la morte proprio con la scrittura. Il primo capitolo, con il sogno angoscioso raccontato in più di due pagine, poi ripreso nel finale, ci immette nel ricordo «inteso come favola». Qualcun altro tra i lettori del gruppo ha proposto anche la possibilità di una decodificazione simbolista (non per nulla Bufalino aveva tradotto Baudelaire): il lettore è immerso in una “foresta di parole”, e sono queste che contano, sicché i simboli sarebbero più importanti dei fatti e della trama. L’importanza di una lingua poetica (che però, per alcuni del gruppo, rende lo stile un po’ “pesante”) è confermata anche dalle aggiunte alla prima edizione, con una prefazione e una serie di poesie. C’è anche la spiegazione lessicale del titolo, in cui si nota il «troppo discorrere» artificioso di una “diceria” (da intendere forse ironicamente se ci riferiamo al libro stesso):
DICERIA: Discorso per lo più non breve, detto di viva voce; poi anche scritto e stampato. Di qualsiasi lungo dire, sia con troppo artifizio, sia con troppo poca arte… Il troppo discorrere intorno a persona o cosa… TOMMASEO-BELLINI
UNTORE: Dispensatore et fabbricatore delli onti pestiferi, sparsi per questa Città, ad estinzione del popolo… (Carte del processo, 1630)
Rifacendosi alla prefazione e soprattutto al glossario di termini letterari usati nel libro, qualcuno ha cercato di dimostrare come l’autore abbia “ostentato” la raffinatezza e la ricercatezza della lingua, esagerando nelle scelte linguistiche che creano “difficoltà” a un lettore comune. L’incipit, per esempio, risulta un “groviglio” inestricabile di parole. A questo proposito, lo stesso Bufalino, nello stesso articolo dell’Espresso del 1981, aggiungeva:
Confesso che il primo capitolo che scrissi fu come un gioco serio: e consisteva nel trovare intrecci plausibili tra 50 parole scelte in anticipo per timbro, colore, carica espressiva. Qualcosa di meno maniacale delle scommesse di Roussel, essendo nel mio caso il legame tra le parole scelte non casualmente ritmico, ne esoterico, ma insorgente da una parentela e coalizione espressiva e musicale, così come da un re, da un sol minore premeditato, nasce una sinfonia…
(«L’Espresso», 1° marzo 1981).
Si è parlato molto, in tutta la serata, dello stile di Bufalino e ci si è chiesti se l’autore non abbia scritto il libro “per sé”, ma la formulazione è risultata, agli occhi di molti, un po’ vaga e non è stata ulteriormente approfondita. Del resto, la complessità di «Diceria» è data anche dalle citazioni nascoste e, come già detto, dai continui riferimenti intratestuali.
Qualcuno ha fatto notare come poca attenzione, fino a questo punto, fosse stata data a tematiche centrali come quella religiosa – si pensi al cap. V e agli aforismi di padre Vittorio –, o a quella della malattia (con un parallelismo evidente con «La peste» di Camus), o a quella amorosa, con il personaggio di Marta. Personaggi come il Gran Magro – dissacrante burattinaio e depositario di verità ben nascoste – e, appunto, Marta (quasi uno specchio degli orrori della Storia e della vita) risultano ben riusciti.
In sintesi, un po’ tutti hanno constatato la complessità del romanzo, alcuni anche criticandola (si è detto che «Diceria» avrebbe bisogno di una sorta di introduzione, o di guida), ma riconoscendo all’autore, nonostante i continui riferimenti alla malattia, alla sofferenza e alla morte, la volontà di suscitare nel lettore la coscienza della brevità della vita e la voglia di vivere.
Un inno alla vita, dunque.
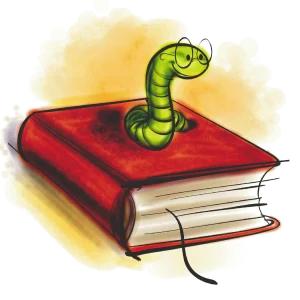



[…] corde tendono indiscutibilmente all’universale. Di Bufalino ci siamo già occupatə qui su blog (UNA SERATA CON GESUALDO BUFALINO AL SETTIMO INCONTRO DEL CAFFÈ LETTERARIO DI ZURIGO, 31 gennaio 201… | estratti da opere di Bufalino ), quindi non mi soffermerò troppo né sulle tematiche né sullo […]
"Mi piace""Mi piace"
[…] CAPOLAVORI, DA TOMASI DI LAMPEDUSA A VISCONTI), Landolfi, Levi, Bufalino (di cui avevo parlato qui: UNA SERATA CON GESUALDO BUFALINO)! Ora chissà se c’è qualcuno che regga al confronto quest’anno, tra le quattro donne che se […]
"Mi piace""Mi piace"
[…] estratti dalla opere di Bufalino), e ripercorrendo le tematiche di Diceria dell’untore in UNA SERATA CON GESUALDO BUFALINO. Quest’anno abbiamo deciso di celebrare questa ricorrenza con una diretta instagram durante […]
"Mi piace""Mi piace"
[…] Bufalino: un ricordo personale, lo stile, e le tematiche UNA SERATA CON GESUALDO BUFALINO AL SETTIMO INCONTRO DEL CAFFÈ LETTERARIO DI ZURIGO, 31 gennaio 201… […]
"Mi piace""Mi piace"
[…] quanto mai stimolanti: un romanzo incentrato sul rapporto tra amore e morte come il capolavoro di Gesualdo Bufalino, «Diceria dell’untore»; il modesto «L’amante» di Marguerite Duras, che comunque sottolinea l’ambiguità del rapporto […]
"Mi piace""Mi piace"