
Niente e così sia è un resoconto del periodo che Oriana Fallaci ha passato in Vietnam come reporter di guerra tra il 1967 e il 1968. L’esigenza di tenere un diario nasce da una conversazione con la sorellina durante la quale la bambina chiede cosa sia la vita e quale il suo senso:
[…] la gente, nel resto del mondo, si chiedeva se fosse lecito togliere il cuore ad un malato cui restano dieci minuti di respiro per darlo a un altro malato cui restano dieci mesi di vita, qui invece nessuno si chiedeva se fosse lecito togliere un’intera esistenza ad un intero popolo di creature giovani, sane, con il cuore a posto. E l’ira mi avvolse penetrandomi sotto la pelle […], e da questa incoerenza crebbe un diario per te, Elisabetta
In realtà però questo libro non è solo un resoconto di guerra, ma è anche una testimonianza di cosa significa davvero essere unA giornalista di guerra in Vietnam. Anche per questa ragione, l’opera coincide con uno scavo interiore della voce narrante che si analizza e si riscopre scrivendo. Tra queste righe troviamo, ai suoi albori, la storia d’amore della stessa Oriana con il giornalista francese François Pelou.
Figlia di questo scavo psicologico è la riflessione sull’eroismo, tema assolutamente dominante e filo conduttore di tutto il libro. Come scrive la stessa autrice, “nessuno resta impassibile all’eroismo”; questa sensazione di vicinanza alla morte, non la spinge a scappare, ma la convince a restare. La guerra in altre parole
non era più un delitto da condannare, ma un eroismo da raccontare. La studiavo in tutte le sue forme […]. La cercavo per me stessa nella sfida di un combattimento aereo
Quanto appena detto non significa certo che Oriana nutra un amore spasmodico o viscerale per il macabro (come qualcuno sembra aver proposto), dubbio che potrebbe essere legittimo alla luce dei molti dettagli anche scabrosi che si ritrovano nelle descrizioni degli orrori perpetrati, sulle vittime. Tuttavia, tale giudizio è smentito dalla ragione dichiarata del realismo romanzato nel quale si collocano queste puntuali descrizioni: la volontà di svegliare l’Occidente. Un Occidente che ancora poco o nulla sapeva di quanto stava accadendo in Vietnam. Oriana non è dominata dall’ideologia, non ci sono vittime o carnefici, nemmeno quando insorgeranno le rivolte studentesche. C’è un concreto tentativo di portare il lettore a riflettere facendo solamente parlare i fatti.
Questo intento è particolarmente evidente nella decisione cosciente di non idealizzare né gli Americani né i Vietcong: non esistono i buoni né i cattivi. Il lettore incontra chiari esempi di eroismo umano in entrambi gli schieramenti. Da un lato, leggiamo degli Americani che muoiono per il dominio di una misera collina 875 e che si ritrovano a dormire sotto i cadaveri, perché tengono caldo. Dall’altro, sul fronte opposto, migliaia di Vietcong lasciano le loro case e la loro famiglia per unirsi nella guerra contro gli invasori, e ci sono anche donne con loro. Il quinto capitolo racchiude due diari di Vietcong ignoti che rendono impossibile al lettore tifare per gli Americani, e così facendo l’autrice pareggia i conti e riallinea la bilancia.
Così come gli eroi sono tanto americani quanto vietnamiti, alla stesso modo le porcherie, alle quali la guerra non sa rinunciare, pullulano da entrambe le parti. Alcuni passaggi, allora, diventano dei chiari esempi
dell’ipocrisia degli americani che poi si presentano con le mani pulite. […] per interrogare i prigionieri […] li portano sugli elicotteri, a coppie, e poi legano uno ad una corda, e lo calano giù […] e quando è ormai mezzo morto gli tagliano la corda. L’altro per non fare la stessa fine, dice tutto. Quando ha detto tutto, lo buttano giù.
E questo è niente se si aggiungono le mostruose descrizioni delle torture psicologiche e fisiche che non rinunciarono certo ad usare come strumenti di interrogatorio già allora.
Tuttavia nemmeno i Vietcong vengono risparmiati nella drammatica e puntuale descrizione dell’offensiva del Tet attraverso la quale verrà presa Saigon. Ma le righe che più condannano il fronte vietnamita sono quelle dedicate all’uccisione di 5 giornalisti Americani e di altri inviati di guerra:
È difficile, sempre più difficile, accettare il fatto che i Vietcong commettano tali vigliaccate. Insomma che neanche loro siano i cavalieri di giustizia e libertà che abbiamo finoggi dipinto. È doloroso, sempre più doloroso, vedere che valgono gli altri, sono bestie come gli alti […].
Da queste riflessioni nasce una domanda che pertiene non solo alla sfera della morale, ma anche del giornalismo. Finora, si è sempre cercato di mostrare l’ipocrisia americana nata dall’accostamento tra democrazia e imperialismo. Quindi c’era sempre un fotografo quando si uccidevano i vietcong, ma sarà stato così anche quando si uccidevano gli Americani?
Ed è così che spero si riesca ad intravedere come la natura stessa di quest’opera si basi sul principio del ribaltamento, in un gioco di specchi che mira ad impedire al lettore di prendere le parti dell’uno o dell’altro schieramento ed è questa la vera forza dell’opera. Oriana raggiunge l’obiettività del resoconto non presentando i fatti nudi e crudi con un verismo esacerbato, non astenendosi dal raccontarci le sue idee, no. Lei ci racconta tutto, proprio tutto, da entrambi i fronti di guerra. Ed è solo così che vediamo la vicenda per quello che è: un massacro in cui nessuno vince e nessuno perde, se non l’uomo.
Alla fine del viaggio, un ultimo capovolgimento: l’eroismo, la tragedia, la morte non hanno più quel fascino che impedivano alla narratrice di stare anche solo due mesi lontana dal Vietnam:
Bambini che piangono, cadaveri a pezzi, colleghi trucidati, crudeltà, orrore: non ne posso più. M’ha invaso come un’esasperazione, una nausea. Qui non c’è né l’uomo né Dio, qui ci sono soltanto bestie.
Per ragioni di spazio, devo soprassedere su altri temi che si ritrovano nella narrazione come quello dell’amore e della morte o del rapporto tra religione e guerra.
Ci tengo però a sottolineare, in conclusione, la necessità di questo libro. Si tratta di un’opera che deve continuare ad essere letta, perché? Prima di tutto perché ci offre un resoconto piuttosto oggettivo della dimensione umana della guerra in Vietnam. In secondo luogo, ci ricorda cosa sia la guerra, che nell’Occidente ci sembra così lontana. Ma soprattutto perché ci invita a pensare alla tortura come mezzo di guerra e di interrogatorio. La democrazia non si esporta e soprattutto non la si può far convivere con la negazione dei diritti umani. Ricordiamoci il Vietnam, ricordiamoci Abu-Gharib e continuiamo a leggere questo libro necessario.
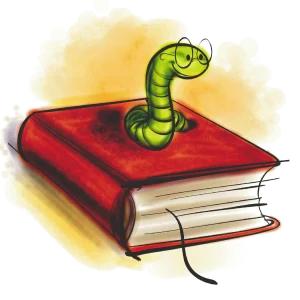
[…] Oriana Fallaci, nata il 29 giugno 1929. Per l’occasione vi abbiamo riproposto l’articolo “NIENTE E COSÌ SIA”: IL LIBRO NECESSARIO DI ORIANA FALLACI […]
"Mi piace""Mi piace"
[…] Fallaci, autrice che avevo scoperto con Se il sole muore e Niente e così sia, di cui scrissi in “NIENTE E COSÌ SIA”: IL LIBRO NECESSARIO DI ORIANA FALLACI. Peggio, molto peggio andò, per quanto mi riguarda, con La rabbia e l’orgoglio che trovai […]
"Mi piace""Mi piace"
[…] “NIENTE E COSÌ SIA”: IL LIBRO NECESSARIO DI ORIANA FALLACI (recensione di Federica Brei… […]
"Mi piace""Mi piace"