di Gerardo Passannante
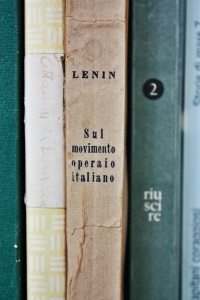
Per il loro connaturato soggettivismo, raramente i poeti sono cantori dell’avvenire dei popoli. Vi si trovano a volte coinvolti dalle circostanze, oppure dall’abbaglio di risolvere il disagio intimo in una causa pubblica. Ma quasi sempre la loro adesione, fondata su un equivoco, sfocia nel disincanto: dal momento che i sommovimenti collettivi, se seducono le masse, sono disattenti ai fremiti estetici e psicologici dei singoli. Sicché raramente un poeta, che non si atteggi a vate, produce qualcosa di artisticamente notevole. Ma tant’è: gli uomini hanno bisogno di officianti, e i tromboni delle magnifiche sorti e progressive sono sempre pronti saltare sul carrozzone da cui gracidare sull’effimero. A questa piaga la musa civile sfugge solo se erompe da scosse autentiche: ma anche quando vibra in cuori generosi, mossa da nobili ideali, è spesso destinata a scontrarsi con la sozzura della Storia, da cui esce umiliata, o piegata a retorica celebrazione, se non peggio…
Né diversamente sono andate le cose con i poeti che in un modo o nell’altro attraversarono la Rivoluzione d’Ottobre: e che, sedotti dalla medusa bolscevica, dopo un momento di ebbrezza iniziale, ne furono inghiottiti; e se sopravvissero, lo poterono solo al prezzo di farsi megafoni del regime o di tacere. Poiché per un poeta autentico non ci sono che due vie davanti alla prevaricazione della politica: o si fa cantore del potere, o soccombe: come dimostra la sorte toccata ai più rappresentativi di loro.
Già famoso per i poemetti I dodici e Gli Sciti, Aleksandr Blok, di formazione simbolista, era già cultore dell’eterno femminino come antidoto al pessimismo decadentista quando incrociò la rivoluzione. Alla ricerca di un raccordo tra amore terreno e divino, credette di risolverlo nel proclamato amore per la Russia, a cui affidare una missione universale. Dallo sforzo di conciliare serenità e disperazione, fulgore patriottico e miseria personale, per un momento poté sognare che il connubio tra arte e politica placasse l’inquietudine con la grancassa bolscevica. Ma dovette ricredersi, se giunse a scrivere: “guai a chi pensa di trovare nella rivoluzione l’adempimento solo dei propri sogni, per alti e nobili che siano… essa porta sempre all’inatteso, e inganna crudelmente…” E da artista puro, non gli restò che intonare i disingannati accordi sull’arpa toccata del vento, come estremo, vano tentativo, di sottrarsi al proprio destino.
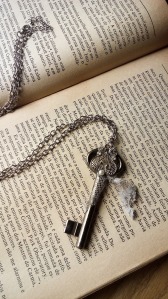
Nato come fervido slancio di rinnovamento, il movimento futurista, cresciuto intorno al gruppo di Lef, dal suo corifeo Vladimir Majakovskij fu inteso come strumento di lotta contro ogni tendenza borghese e reazionaria. Contornato da molti altri poeti, narratori e saggisti, egli fu però il solo a sollevarsi su questo gregge di aedi della rivoluzione, prima che sfociasse in regime. In essa Majakovskij aveva creduto di discernere l’atmosfera idonea alla propria estrinsecazione. E mescolò, tra metafore e iperboli, frizzi sentimentali e ideologici, esibizionismo e ideologia, in un impasto di plateale e melodrammatico, scagliando in faccia al mondo invettive che puntualmente gli si rivolsero contro. Così, nel transito pronominale dall“io” al “tutti”, pretesa cifra di una poesia proletaria, nel poema 150.000.000 proclamò a ripetizione che “Lenin visse / Lenin vive / Lenin vivrà / Lenin il più grande dei grandi.” Ma il poema della massa e per la massa non risolse la solitudine nella tensione espressionistica, non collegò il suo arco esistenziale con quello storico: sicché al forzato (e fallito) inserimento dello zelo propagandistico nella coscienza sociale, il poeta non seppe che rimediare col suicidio.
Tutto perirà / ridotto a niente / è colui che muove la vita /brucerà l’ultimo raggio / dell’ultimo sole? /contro l’oscurità dei pianeti. /E c’è soltanto il mio dolore / più acuto. Cinto dalle fiamme / io resto / sul luogo eterno/ dell’amore impossibile.
Dal Futurismo presero avvio movimenti più effimeri, come il Proletkult, il Costruttivismo e l’Immaginismo. A quest’ultimo, sorto nel ’19, aderì Sergej Esenin, considerandolo una corrente idealistica in cui far confluire la ribellione delle masse contadine della vecchia Russia. Poeta dell’istinto, legato a una primordiale religiosità mistico-simbolica della campagna sentita con malinconia, questo vagabondo “teppista” della steppa, nella forzatura di allontanarsi dalle origini per andare verso la città, fu travolto dalle sue artificiose tentazioni. Così, la Rivoluzione costituì per Esenin l’esca fatale al cammino creativo, destinata a strozzare la sua confusa utopia. Né gli bastò volgersi indietro, per sfuggire alla tecnica del comunismo, e inseguire quella civiltà patriarcale che aveva mitizzato e che la ruspa rivoluzionaria aveva spazzato, accentuando la nostalgia della madre terra e il rimpianto dell’infanzia contadina: così che, incapace di adattarsi al processo industriale, Esenin, a trent’anni, si impiccò in una stanza d’albergo di Leningrado, dopo avere scritto col sangue gli ultimi versi:
Morire non è cosa nuova sotto il sole:
ma cosa nuova non è nemmeno vivere.
Al Costruttivismo, che si protrasse fino al Congresso degli scrittori sovietici del ‘34, si rapportarono molti insignificanti poeti che cercarono di conciliare momenti classici con l’adesione al realismo sovietico. Sui nomi più significativi di Nikolàj Tìchonov e Ilia Erenbùrg, che dopo aver scritto della barbarie del comunismo si accomodò a vivacchiare nel regime, spicca quello di Borís Pasternàk, ripiegato con orgogliosa resistenza interna sul diuturno lavoro di traduttore, prima che l’esplosione mondiale del Dottor Zivago lo sollevasse agli onori della cronaca e all’infamia della reprimenda. Già da molti considerato il maggiore poeta russo vivente, Pasternàk, dopo un’iniziale adesione al Futurismo, nella sua duplice fisionomia di Chlèbnikov e Majakovskij, prese le distanze dalla poesia politicizzata di quest’ultimo, diventatagli “incomprensibile”, per esprimere una sensibilità prerivoluzionaria che cercava non la rottura ma il rapporto con tradizione di accentuata sfumatura filosofica di un Solovëv e di un Tjutčev.
Formatosi a contatto con la cultura occidentale, e in possesso di un’ottima preparazione anche musicale, negli anni travolgenti del comunismo, impossibilitato all’obiettività epica, Pasternàk recuperò il senso cosmico della natura. Né a questa sensibilità lirica venne meno, anche dopo la fama del romanzo, la visione romantica per cui l’arte, anche se non è veritiera esteriormente, deve rispondere alla fedeltà interiore della creazione, e non può sgorgare se non nella solitudine dello spirito distaccato, benché non estraneo alla realtà sociale, come reazione al filisteismo e protesta umanistica contro l’ottundimento delle cose, così che l’orizzonte della libertà si situa oltre l’apparente indifferenza del mondo.
Fine dell’opera e dare tutto di sé.
E non il successo, lo scalpore.
È vergognoso, quando non si è nulla,
diventare per tutti una leggenda.
…
E neanche di un minimo
deve venire meno all’uomo,
ma essere vivo, vivo e null’altro,
vivo e null’altro sino alla fine.
Questo il diversamente tragico destino toccato a coloro che sono considerati i massimi rappresentanti dell’avanguardia russa del Novecento. Ognuno dei quali, muovendo da una complessa costellazione esistenziale, si schiantò a contatto con la dimensione sociale. Consapevoli della frattura irrevocabile con il realismo ottocentesco, già denunciato da Mereškovskij, e al tempo stesso alla crisi dell’individualismo davanti alla “macchina” del potere, questi poeti, accomunati dall’utopia come disposizione d’animo destinata a restare tale o a infrangersi al cozzo col reale, emisero, ognuno a suo modo, il medesimo grido dell’umano contro l’inumano di un’ideologia antropofagica. Così, se Esenin trovò un’altra terra nel suicidio a trent’anni, e Majakovskij affidò alla pistola la delusione di essere stato amplificatore della menzogna, Blok non sopravvisse all’inaridirsi della vena davanti alla brutalità del reale. Solo a Pasternak fu consentito, al prezzo del silenzio, di rielaborare dentro di sé, per il resto dei suoi giorni, il tradimento della Storia…
Fonti:
Ettore Lo Gatto, Storia della letteratura russa, Sansoni, 1964
Giovanna Spendel, Storia della letteratura russa, Tascabili economici Newton, 1996
Renato Poggioli, Il fiore del verso russo, Oscar Mondadori, 1968
Poeti russi della rivoluzione, a cura di Bruno Carnevali, Newton Compton 1971
Vladimir Majakovskij, Poesie, a cura di Maria Roncali Doria, Newton Compton, 1973
Sergeij Esenin, Poesie, a cura di Bruno Carnevali, Newton Compton, 1975
Boris Pasternak, Poesie, a cura di Angelo Maria Ripellino, Einaudi, 1957
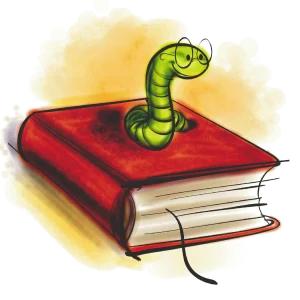
[…] la politica e la letteratura nel periodo della Rivoluzione d’ottobre. Nell’articolo di Gerardo Utopia e rivoluzione (russa) riecheggiano le storie di alcuni tra i più celebri autori della letteratura russa del ‘900: […]
"Mi piace""Mi piace"
[…] scorsa, la terza diretta del gruppo di lettura 🕰 GdL Proust ritrovato in occasione della quale Gerardo e io abbiamo attraversato la prima parte del secondo volume della Recherche, All’ombra delle […]
"Mi piace""Mi piace"
[…] scorso la quarta diretta del gruppo di lettura GdL Proust ritrovato in occasione della quale Gerardo e Maresa hanno attraversato la seconda parte del secondo volume della Recherche, All’ombra […]
"Mi piace""Mi piace"
[…] La Citazione del giorno – 6 agosto 2022 di Vladimir Solov’ëv (autore cui si accennava in Utopia e rivoluzione (russa) […]
"Mi piace""Mi piace"
[…] Utopia e rivoluzione (russa) […]
"Mi piace""Mi piace"