Il nome di Michail Bulgakov e «Il Maestro e Margherita» sono indissolubilmente legati. Perseguitato dalla censura sovietica, l’autore non poté vedere pubblicata la sua opera nella sua versione integrale, uscita postuma. Iniziò a scrivere il romanzo nel 1928, morì nel 1940 e la moglie ne terminò la stesura un anno dopo; la pubblicazione del ‘67 è la versione definitiva. Il successo e la fortuna letteraria a livello internazionale e nella stessa Russia sancivano la vittoria della libertà d’espressione nei confronti del regime sovietico, ma Bulgakov non poté assistere alla propria rivincita.

Il caffè letterario di Zurigo, riunitosi il 29 marzo, ha discusso il valore e i significati dell’opera, in un clima disteso e al tempo stesso attento e partecipe.

Opera misteriosa, dalla trama complessa e articolata secondo tre filoni narrativi – la discesa del diavolo (Woland) a Mosca, Ponzio Pilato e il processo a Gesù, l’amore tra il Maestro e Margherita -, il romanzo di Bulgakov accoglie in sé stili e registri diversi, dal grottesco al dramma, dal burlesco al lirico, dalla parodia al mito, ed esprime tutto il disprezzo dell’autore nei confronti dei critici letterari sovietici e di tutti i moscoviti, conformisti e asserviti al potere. Il motivo polemico percorre tutta la vicenda di Woland e dei suoi accoliti, capaci di mettere Mosca a soqquadro, effettuando la vendetta di tutti coloro a cui si impedisce di creare e di esprimersi liberamente nell’arte e nella società: una satira, quella nei confronti della società moscovita e del potere sovietico, che non poteva passare inosservata nella Russia di Stalin. Le imprese di Woland, Azazello, del gatto Behemot, della strega Hella e degli altri accompagnatori diabolici (la morte del critico Berlioz, lo spettacolo di varietà, il ballo satanico, il volo su Mosca) realizzano con il ricorso al soprannaturale e alla fantasmagoria questo programma di riscatto dall’oppressione del potere in nome della giustizia. A questo ideale è dedicato anche il romanzo di Ponzio Pilato, uomo angosciato per aver permesso il supplizio del mite predicatore Jeshua Ha-Nozri, di cui lo ha colpito la sua assurda fiducia nella bontà dell’uomo. La vicenda del processo a Cristo irrompe già nel secondo capitolo e riaffiora periodicamente in tutto il romanzo, finché Ponzio Pilato nel finale viene liberato dal suo rimorso dallo stesso Maestro che, come ha scoperto il lettore, è autore del manoscritto che racconta la sua storia. L’amore di Margherita per il Maestro le ha dato la forza di assecondare la magia nera di Woland, che l’ha resa strega e l’ha fatta partecipare al ballo satanico; Woland stesso esaudisce il desiderio di Margherita di far comparire il manoscritto bruciato dal Maestro, testo contenente il romanzo di Ponzio Pilato, affermando che
I manoscritti non bruciano.
Evidente qui il messaggio autoriale: la letteratura risorge sempre, e non sarebbe così se non fosse portatrice di valori.
Margherita, protagonista della seconda parte del romanzo, ne conduce qui l’azione principale, mentre altri personaggi meno centrali, come Levi Matteo, l’unico evangelista, e il poeta Ivan, testimone delle vicende moscovite, costituiscono elementi di congiunzione necessari tra i vari piani narrativi.
Forse il ricorso al fantastico, con la vittoria di Woland, con la vendetta di Margherita e del Maestro e con la loro ascesa alla perfezione celeste, esprime una visione pessimistica del mondo, giacché la realtà storico-politica che circondava Bulgakov non pareva consentire un’effettiva liberazione dal potere. Non per niente Bulgakov si dichiarava mistico e nel romanzo l’irrazionale infrange le regole conformistiche della razionalità sociale. Ma questa è sostanzialmente un’interpretazione.
L’epigrafe tratta dal «Faust» di Goethe (indiscutibile fonte primaria de «Il Maestro e Margherita»), con cui si apre il libro, rivela comunque qualcosa di più concreto e certo e spiega il ricorso al maligno come estrema risorsa per accedere al bene:
-
Ma allora chi sei tu, insomma?
-
Sono una parte di quella forza che eternamente vuole il male ed eternamente compie il bene
A una lettura approfondita i grandi temi del Potere, della Verità e della Giustizia risultano trasversali a tutte le vicende del romanzo, ma è soprattutto nella vicenda di Ponzio Pilato che essi affiorano ed emergono più nettamente, nell’attualità di un personaggio moderno tormentato dal dubbio, dall’errore compiuto e da un senso di colpa che ha qualcosa di metafisico, di assoluto. E il collegamento con la massima di Goethe è chiaro: il libero dispiegamento dell’unione tra il Maestro e Margherita, con la salvezza del libro sulla Passione da lui scritto, è consentito dall’autorità di Woland, cioè da Satana, perché gli uomini stentano a realizzare il bene. Nel capitolo in cui si decide il destino di Margherita e del Maestro, il XIX, Woland risponde a Levi Matteo, che in modo malevolo non vuole augurargli salute, dicendo che le ombre e il male vanno sempre riconosciuti:
Non vorresti avere la bontà di riflettere sulla questione: che cosa farebbe il tuo bene, se non esistesse il male? E come apparirebbe la Terra, se ne sparissero le ombre? Le ombre provengono dagli uomini e dalle cose.
Poco dopo Levi Matteo, mandato da Gesù, dice a Woland, a proposito del Maestro:
Non ha meritato la luce, ha meritato il riposo.
E riposo avranno, il Maestro e Margherita, grazie a Woland, in una sorta di felicità perpetua.
Come negli altri incontri del Caffè letterario, i lettori hanno confrontato tra di loro le diverse esperienze di lettura. Alcuni hanno incontrato qualche difficoltà a causa dei tanti personaggi e della trama piuttosto intricata, mentre altri hanno trovato un po’ ridondanti, o comunque meno rilevanti, i tanti capitoli dedicati alla banda di Woland e alla sua incursione nel mondo sovietico; alcuni particolari sono sembrati troppo insistiti, o addirittura superflui. Le parti sataniche, in un caso, hanno avuto un effetto ansiogeno. Qualche riserva è stata fatta anche sulla dimensione psicologica dei personaggi e sul rapporto Maestro-Margherita, poco caratterizzato dal lato erotico, nonostante i “proclami” sull’amore eterno da parte della voce narrante all’inizio della seconda metà. Vero è, in ultima analisi, che il Maestro e Margherita alla fine di tutto vivranno eternamente, ma non nella dimensione terrena e temporale.
È stato anche letto il commento di Eugenio Montale, che considerava «Il Maestro e Margherita» una sorta di miracolo letterario:
Un romanzo-poema o, se volete, uno show in cui intervengono numerosissimi personaggi, un libro in cui un realismo quasi crudele si fonde o si mescola col più alto dei possibili temi – quello della Passione – non poteva essere concepito e svolto che da un cervello poeticamente allucinato. E’ qui che il poco noto Bulgakov si congiunge con la più profonda tradizione letteraria della sua terra: la vena messianica, quella che troviamo in certe figure di Gogol’ e di Dostoesvkij e in quel pazzo di Dio che è il quasi immancabile comprimario di ogni grande melodramma russo.
Nel complesso, che l’opera di Bulgakov sia un classico capace di far immedesimare nella vicenda qualsiasi lettore e di generare continui problemi interpretativi, è un parere che ha trovato d’accordo tutto il gruppo.

In margine alla discussione sul romanzo, sono stati presentati due autori: Valeria Pinti, autrice di «Ada», e Gerardo Passannante, autore de «L’ora della mezzanotte». A quest’ultimo libro verrà dedicata una serata speciale, da organizzare prossimamente.
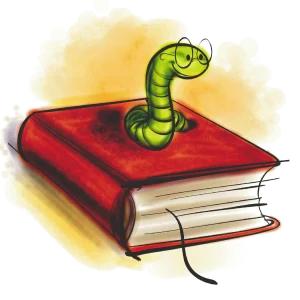
[…] La Citazione del giorno – 11 marzo 2023 di Michail Afanas’evič Bulgakov, il cui Il maestro e Margherita era stato protagonista di una delle serate de Il caffè letterario a Zurigo: «Il Maestro e Margherita» di Bulgakov e il Caffè Letterario di Zurigo (recensione di Vittorio&nbs… […]
"Mi piace""Mi piace"
[…] alla stesura del romanzo che lo avrebbe reso famoso: Il maestro e Margherita (recensito in «Il Maestro e Margherita» di Bulgakov e il Caffè Letterario di Zurigo). La scrittura occupò interamente gli ultimi dodici anni della vita dell’autore, durante i quali […]
"Mi piace""Mi piace"
[…] sottolinea l’ambiguità del rapporto tra amore e sessualità; il grande e complesso romanzo «Il Maestro e Margherita» di Bulgakov, che al tema dell’amore aggiunge il problema del male e del potere, con la discesa del diavolo […]
"Mi piace""Mi piace"