Gerardo Passannante
In queste ore drammatiche per l’Ucraina, con la speranza che la diplomazia riesca e che la situazione non degeneri oltre, più che solidarietà non si può offrire molto al suo popolo. Ma pur nell’impotenza di alleviarne la sofferenza, dal mio modesto osservatorio non mi sembra inutile ricordare che anche il patrimonio storico-culturale è qualcosa di cui fregiarsi davanti ai pretesti che il cinismo adotta per mascherare il delirio. Se il primo pensiero va dunque d’obbligo a chi muore, e alla popolazione inerme che subisce la furia dell’autocrate che, muovendo pezzi sulla scacchiera, ignora lo strazio di migliaia di famiglie, di fronte all’immane catastrofe c’è quasi da vergognarsi a parlare di letteratura. Ed è perciò con pudore che rendo omaggio a questo paese, ricordando che chi lo calpesta gli è tributario del germe primo, senza cui forse non avrebbe visto le vette di Puškin, Dostoevskij e Tolstoj.
La cultura russa prende infatti le mosse proprio in Ucraina. Qui, nel decimo secolo, erano confluiti i normanni svedesi, detti variaghi o ruotsi (da cui il nome Russia), chiamati dagli stessi slavi desiderosi di mettere fine alle loro discordie interne. Ma se quei mercanti guerrieri avevano portato armi e merci, fu il cristianesimo a mettere in contatto i dialetti slavi orientali con quello macedone di Metodio e Cirillo, che per la loro opera di evangelizzazione avevano creato un alfabeto idoneo alla traduzione dal greco in una lingua paleoslava. E che trovò terreno fertile in Russia, quando la conversione nel 988 del principe di Kiev Vladimir, unificando le tribù tra il Mare del Nord e il Mar Nero, permise un’ampia diffusione di testi religiosi, liturgici o agiografici.
Si poté così assistere al fiorire di una produzione apocrifa, come il Vangelo di Ostromìr, la Storia di Alexeij, il Romanzo di Alessandro, le Storie di Troia, la Saga del Regno Indiano, il racconto di Akir il saggio e quello di Varlaàm e Josaphat, Il pellegrinaggio della madre di Dio attraverso le pene, La leggenda del viaggio del Santo Andrea in Russia. Su questa produzione apocrifa spicca la figura di Ilarion, la cui professione di fede stilata in Della legge e della grazia diede inizio all’arte letteraria di Kiev. Seguito da Kliment di Smolènsk, autore di un’Epistola al prete Fomà; da Kirìl di Turov, artefice di numerosi sermoni su modelli bizantini; e soprattutto da Nestor, il primo cronista originale. La cui Cronaca degli anni passati, redatta a Kiev nel 1037, già denuncia il contrasto tra il luminoso stato antico della sua terra e la cupa condizione in cui è piombata a causa del popolo dei pòlovcy. Il lamento contro l’invasore, come una costante, risuona ancora nelle nenie delle byliny, così intrise di leggende e sconforto. Ma dove il gemito per la libertà perduta si fa più toccante è nel poema epico Il canto della schiera di Igor,compianto per la sorte toccata nel 1185 a questo sfortunato principe.

Dello stesso tenore è ancora l’Ammaestramento ai figli di Vladimir Monomach, che, per difendere la sua terra dagli invasori, biasima la discordia dei signori. E profeticamente: giacché furono proprio i contrasti interni a favorire la fatale invasione nel 1223 di genti di lingua e fede sconosciute, detti tatari o mongoli, che misero fine a quella felice stagione. Benché la decadenza di Kiev fosse già cominciata col defluire delle popolazioni meridionali verso territori settentrionali, fu l’occupazione dei tatari a darle il colpo di grazia. Senza però impedire che la sua cultura trasmigrasse altrove, e che il suo spirito mutasse le non dismesse energie nella pittura religiosa di Novgorod, Smolensk, e Rostov, o si chiudesse al riparo dei monasteri. Mentre la sua eredità letteraria, confluendo nel principato di Mosca, segnò l’inizio della grande letteratura russa.
Che forse però non si sarebbe affermata senza il germe attecchito presso quel popolo ucraino, nella cui determinazione oggi riudiamo l’antico appello alla libertà, da salvaguardare anche a rischio della vita. E che, in un mondo dove economia e profitto si ergono a imperativi morali, ci ricorda che la lotta per un ideale smette di essere retorica quando si macchia di sangue; che la dignità non è contrattabile; e che, al di sopra delle convenienze che obnubilano le coscienze, i princìpi non sono retaggio di ostinato nazionalismo, ma faro per chiunque rifiuti di ridursi a comodo fruitore di benessere.
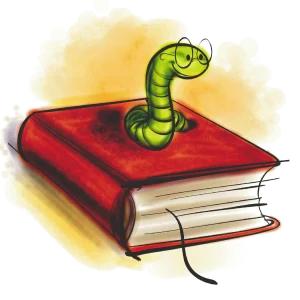

[…] da Gerardo, e incentrato sulla nascita della letteratura ucraina e russa, e il rapporto che lega: Ucraina: la culla della letteratura russa. L’idea era quella di offrire un «omaggio a questo paese, ricordando che chi lo calpesta gli […]
"Mi piace""Mi piace"
[…] stato del resto seguendo questa linea di pensiero che dopo Ucraina: la culla della letteratura russa abbiamo deciso di proporvi, proprio questa settimana, un altro articolo dedicato alla Russia. Si […]
"Mi piace""Mi piace"
[…] Ucraina: la culla della letteratura russa […]
"Mi piace""Mi piace"
[…] aspetti grotteschi e surreali tipici della tradizione russa. Nasce nel 1809 a Sorotchinci, in Ucraina, da una famiglia di possidenti terrieri. Trascorre l’infanzia a Vasilevka, una delle […]
"Mi piace""Mi piace"
[…] oggi, il 15 maggio 1891 a Kiev un esponente fondamentale della letteratura in lingua russa: Michail Bulgakov, autore di teatro, […]
"Mi piace""Mi piace"
[…] Ucraina: la culla della letteratura russa […]
"Mi piace""Mi piace"