
Esattamente cento anni fa, il 3 giugno del 1924, moriva nel sanatorio di Kierling, vicino Vienna, Franz Kafka, uno degli scrittori capitali del Novecento. Era nato da Julie Löwy e da Hermann il 3 luglio del 1883 a Praga, crocevia della cultura slava, ceca, tedesca ed ebraica, primogenito di sei figli, di cui due fratelli morti in tenera età, e tre sorelle poi sterminate nei campi di concentramento nazisti.
Concluso il ginnasio tedesco della città, all’università passò da chimica a germanistica, per laurearsi infine in legge. Quindi lavorò per una compagnia di assicurazioni, in un ambiente grigio da cui trasse non solo lo sfondo squallido di alcune narrazioni, ma anche la spinta a evadere nella scrittura, per contrastare il deserto del mondo. Esordì nel 1904 con i racconti contenuti in Descrizione di una battaglia e in Preparativi di nozze in campagna (1907); e intanto aveva preso a frequentare alcuni intellettuali (tra cui il giovane Einstein), e a viaggiare a Lugano, Milano, Montichiari, dove per la settimana aviatoria ebbe modo di incrociare D’Annunzio e Puccini (1909).
Del 1912 sono i primi grandi testi, come La condanna (titolo quanto mai emblematico) e soprattutto La metamorfosi: storia sconvolgente del commesso viaggiatore Gregor Samsa, che svegliandosi una mattina si trova tramutato in scarafaggio, ed è costretto fino alla morte a subire le vessazioni del suo stato scandite da leggi inderogabili… Ma intanto Kafka si era fidanzato con Felice Bauer, con cui, tra abbandoni e riprese, scambierà un importante epistolario; e aveva messo mano al Processo, scorgendo persino qualche prospettiva di successo col premio Fontane (1915) quando la sorte mutò brutalmente con la diagnosi di tubercolosi polmonare, che lo costrinse d’allora in poi a lunghi soggiorni in sanatorio. La salute precaria, se pure sopportata con stoicismo, gettando un’ipoteca sul futuro non mancò di incidere sui racconti di quel periodo, come Un medico di campagna e Nella colonia penale, e lasciò una drammatica traccia nella famosa Lettera al padre del 1919, implacabile atto di accusa contro il potere dispotico della famiglia e della società.

Da Merano, dove si era spostato per curarsi, Kafka iniziò il carteggio con Milena Jesenská, traduttrice dei suoi primi racconti, con cui visse una conflittuale storia d’amore, per il rifiuto di lei di lasciare il marito. Ma scrisse Il castello (1922), La tana (1923), Il digiunatore (1924), prima di spostarsi nel sanatorio di Vienna, assistito fino alla morte dalla sua ultima compagna, Dora Dymant. Ma già prima, sentendone le avvisaglie, aveva dato disposizioni per il lascito letterario. Solo che se talvolta un amico insospettabile, per rivalsa o frustrazione, scade a piccinerie, può anche succedere che un altro tradisca per devozione. E fu questo appunto il caso di Max Brod, a cui Kafka aveva affidato l’esecuzione testamentaria di tutti i materiali inediti, gli epistolari con Milena e Felice, i diari, i resoconti, e soprattutto i romanzi America, Il processo e Il castello, tutti incompiuti, col compito di distruggerli. Bene, Max Brod, con la convinzione di compiere un’opera meritoria, e forse assecondarne sotto sotto l’intimo volere, non ne rispettò l’estrema volontà, compiendo l’atto di disubbidienza a cui dobbiamo la fortuna di leggere quelle opere destinate al macero.
Se già inAmerica (1927), di cui in precedenza era stato pubblicato solo il primo capitolo col titolo Il fuochista, assistiamo alla solitudine di un adolescente inviato a espiare un’ingenua vicenda sentimentale in una America da Luna Park, nella cui baraonda si smarrisce, l’angoscia si fa più tesa nei due grandi romanzi della maturità. Il Processo (1924) narra la storia dell’impiegato di banca Joseph K. (da notare il cognome!), che un bel mattino (e i risvegli di Kafka più che sancire la fine del sogno inaugurano l’ingresso nell’incubo della realtà) viene arrestato, senza avere la minima idea del perché. Per tutto il romanzo cerca invano di provare la sua innocenza, schiacciato da una macchina processuale misteriosa e insondabile, in una città che si rivela un immenso tribunale, dove tutti sono a conoscenza del congegno che lo stritola nel suo ingranaggio. Altro non gli resta allora che attendere l’esecuzione della condanna come ineluttabile esito della solitudine di un uomo senza affetti, costretto a piegarsi a una acefala esecutrice di giustizia che ne decreta la morte “come un cane”.

Di aura diversa, ma non meno angosciante, è la vicenda de Il castello (1926), dove assistiamo alle peripezie dell’agrimensore K. (badate bene, ancora K.!), che, convocato da un’autorità arcana, non riesce a inserirsi nella comunità circostante. Così che poco a poco il castello inaccessibile si rivela come la sede di una mostruosa e ostile burocrazia, dove schiere di funzionari muovono congegni illogici, che gli abitanti del villaggio trovano invece naturali. E quando poi anche la ragazza che vorrebbe sposare lo abbandona, K. sente che la partita è irrimediabilmente persa, e stanco e assonnato si ritira in una camera d’albergo… A questo punto però il romanzo si interrompe, lasciando solo ipotizzare la sua probabile fine…
La caratteristica compositiva di queste opere (oltre all’incompiuto) sta nel “corto circuito tra l’immensamente piccolo del simbolo e l’immensamente grande della realtà simboleggiata” (Foà), tra la meschinità dei personaggi e la grandezza del certame che l’uomo ingaggia con se stesso, con la società e con Dio. E il tutto è detto in uno stile disadorno e sobrio, vicino all’asciuttezza del linguaggio giuridico ben noto a Kafka. A questa scarna espressione fa però riscontro una complessa trama simbolica e metaforica, che immerge le scene in una dimensione onirica, oscura e incontrollabile, dove salta ogni schema. Non sorprende pertanto che se ne siano date interpretazioni plurime. Così, alla proposta metafisica di Max Brod, che individua nell’opera di Kafka il dissidio della trascendenza ebraica, si sono affiancate le letture di Camus e Sartre, che hanno visto in lui l’interprete dell’assurdo esistenziale; quelle sociologiche (Lukács, Benjamin e Adorno) che vi hanno scorto il dramma del singolo nell’alienazione capitalistica; quella psicoanalitica, freudiana, junghiana o lacaniana…
Interpretazioni tutte legittime e nessuna esaustiva, a riconferma della poliedricità del discorso kafkiano, che, sfuggendo a qualsiasi ideologia si fa interprete del disagio universale dell’uomo che si scontra con una “volontà” senza volto e statuto, contro il cui silenzio si infrange ogni istanza di salvezza. Con la caduta delle illusioni resta così solo la vana tensione a una felicità qualsiasi, che attrae e respinge, che seduce e condanna, caoticamente, senza scopo e progetto, senza logica e fini. Ché se poi, vogliamo contestualizzare la “cornacchia” (questo il significato di Kafka in ceco) per sentirla attuale, non ci basta la minaccia del presente dominato da entità refrattarie al dialogo, e su cui, tra instabili equilibri e bagliori luciferini, plana una terrificante brezza di catastrofe?

Abbonati a Giornate di lettura
Unisciti gratuitamente a centinaia di nostri abbonati e abbonate, e sii il primo a ricevere nuovi contenuti.
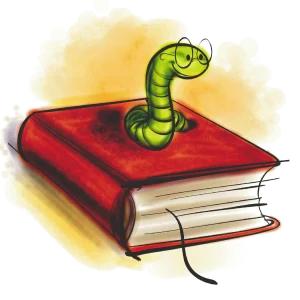

[…] fecondo di anniversari, quello di giugno! Abbiano appena ricordato il centenario della morte di Kafka, ed ecco che subito si fa avanti a richiedere il dovuto omaggio un altro colosso, al quale peraltro […]
"Mi piace""Mi piace"
[…] 100 anni di Franz Kafka: la taccola inquieta(nte) […]
"Mi piace""Mi piace"
[…] occhi del padre.La lettera, in ogni caso, costituisce un prezioso documento per conoscere l’uomo Franz Kafka, non un personaggio fittizio. Fin dall’incipit egli dichiara la paura che gli incute il padre e […]
"Mi piace""Mi piace"
[…] Altra stretta parentela potrebbe avere con i protagonisti kafkiani del Processo e della Metamorfosi: uomini ordinari, sopraffatti da un mondo opprimente e indecifrabile e giudicati senza appello, […]
"Mi piace""Mi piace"