Briciola di filosofia #28
Trovate le puntate precedenti, sulla pagina dedicata a questa rubrica: Briciole di filosofia

Si dice comunemente che con Socrate la filosofia segna un punto di svolta, per la ricerca spostata dalla natura all’uomo. Questo, come già sappiamo, è vero solo in parte, visto che quella rivoluzione l’avevano operata anche i sofisti con i quali Socrate condivideva quel fondamentale approccio, ma dai quali prendeva anche le distanze. In un contesto democratico, in cui tutti potevano affermarsi se ne avevano gli strumenti e la capacità, i sofisti tendevano a comprendere la natura umana, per sfruttarla ai fini del profitto e del successo. Per Socrate invece la ricerca doveva essere un atto di pura conoscenza. Il suo soggettivismo pertanto era quello di chi riteneva vero non indiscriminatamente ogni verità, o nessuna, ma ciò che risultava dopo un adeguato esame critico, incentrato su una fondamentale conoscenza di sé, in osservanza al motto inscritto sul Frontone del Tempio di Apollo, a Delfi, che prescriveva appunto il gnoti s’auton (conosci te stesso).
Ma come ottenere questa conoscenza? Essa non è data per scienza infusa o per grazia divina. Occorre perseguirla continuamente, con umiltà e serietà, non partendo dal presupposto di insegnare preziose verità agli ignoranti che desiderano acquisirle, no, ma da quello della propria insipienza, perché solo chi ha la mente aperta può lasciare spazio all’acquisizione. Si capisce allora che contro la sicurezza con cui i venditori di ciance si offrivano agli allocchi, Socrate ricordava con apparente modestia l’esito della richiesta di Cherofonte all’oracolo di Delfi, che lo definiva l’uomo più sapiente di Atene. Incredulo, e intenzionato a smentirlo, egli si era messo allora a intervistare politici, poeti, artisti, ogni volta facendosi dei nemici, ma ogni volta constatando che davvero il più sapiente era lui: perché mentre quelli andavano tronfi di un sapere inesistente, lui era superiore almeno nella consapevolezza per cui, non possedendo alcuna verità, non si riteneva maestro di niente, e proprio per questo superava la presunta sapienza di quegli illusi incapaci persino di realizzare la propria ignoranza.
Già, poiché solo la liberazione da un sapere apparente, unita alla consapevolezza di non sapere, genera quel salutare disorientamento (aporia) che è condizione preliminare per la conoscenza. Se chi è pieno di sé non è nella disposizione di aprirsi alla ricerca, colui che dopo un percorso difficile giunge alla consapevolezza entra in uno stato di irrequietezza che lo sprona alla verità, contro la boria dei millantatori.
Ma in questa riconosciuta insufficienza, come stabilire una verità, e quale metodo adottare per la conoscenza di sé? E del resto che insegnamento poteva mai impartire, uno che sapeva di non sapere, al nugolo di giovani che lo attorniavano? Non è facile dirlo, visto che Socrate non scrisse nulla, e tutto ciò che ne sappiamo ci viene soprattutto da Platone che ne fece il protagonista della maggior parte dei suoi Dialoghi, aprendo peraltro una questione di autenticità. Da altre fonti riusciamo a dedurre che fu un personaggio piuttosto scomodo nel vivace contesto ateniese, dove si muoveva come un tipo originale, curioso di novità ma legato alle tradizioni, e spiccava per stranezza di carattere e contrasto tra la disarmonia fisica e la bellezza interiore. Altre testimonianze ce lo presentano paziente e tollerante, in grado di sopportare le fatiche, il freddo e la fame, ma anche dedito ai piaceri della tavola e non solo; assetato di conversazione, ma capace di isolarsi per concentrarsi (come la volta che restò per un’intera giornata e un’intera notte in piedi, meditando); brillante imbastitore di volteggi su questioni apparentemente di poco conto, ma che poi si rivelavano astuzie per giungere alla verità a cui tendeva in obbedienza al dettato interiore del daimon che di continuo lo spronava alla sua missione di conoscere se stesso e gli altri, come riporta Platone nella sua Apologia.)
Ma, appunto, qual era questa verità che Socrate inseguiva? Dove si trovava? Che significava conoscere se stesso e gli altri? E con quali strumenti e tecniche la investigava? Ecco quanto cercheremo di capire nel prossimo numero.

Iscriviti per non
perdere i nostri articoli
Unisciti gratuitamente a centinaia di nostri abbonati e abbonate, e sii il primo a conoscere nuovi contenuti.
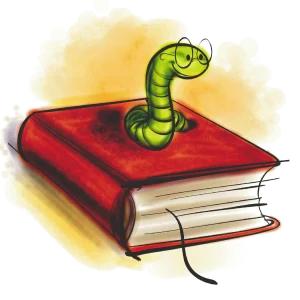
[…] Socrate: come possiamo conoscere davvero noi stessi? […]
"Mi piace""Mi piace"