Moriva oggi, nel 1623, William Shakespeare, il massimo poeta inglese, e uno dei maggiori di tutti i tempi. Un veloce profilo come questo non può dare che una pallida idea della sua grandezza smisurata. Ma se invoglierà qualcuno che non l’abbia ancora fatto a prendere in mano una delle sue opere, avrò compiuto la mia buona azione quotidiana. In ogni caso, mentre buttavo giù questi appunti, io stesso mi sono sentito catapultato indietro al primo approccio che ebbi con lui intorno ai 16 anni, quando ricevetti in regalo un volume con tutte le opere. E da allora, anche se con larghi intervalli, non ho più smesso di leggerlo.
E vediamolo un po’ più da vicino, questo “barbaro non privo di ingegno” (secondo la celebre definizione manzoniana), che, nato a Stratford-on-Avon il 23 aprile del 1564 vi morì nello stesso giorno del 1616: data in cui il cielo dell’arte si oscurò di brutto, visto che mezzo meridiano più ad occidente si spegneva contemporaneamente un altro sommo di nome Cervantes.
Se la madre discendeva da una famiglia di possidenti, il padre, appartenente alla corporazione dei pellai e guantai, doveva godere di un certo prestigio sociale, visto che giunse a ricoprire la carica di sindaco. Dalla loro unione nacquero ben 8 figli, di cui non sappiamo niente, se non che William era il terzogenito. Nella cittadina natia il ragazzo ottenne una discreta educazione, e forse ebbe anche modo di frequentare qualche semestre a Oxford, prima che l’irruenza del sangue lo costringesse a interrompere gli studi per convolare a nozze con Anne Hathaway, una donna di 8 anni maggiore, che uno dopo l’altro gli partorì tre figli.
Avendo il padre subìto un tracollo finanziario, come il poeta abbia potuto sostenere la famiglia d’origine e la propria non è dato sapere, essendo spuria la notizia che lo vuole maestro di scuola. Probabilmente dovette arrabattarsi alla meglio con lavoretti non sempre leciti, se vogliamo prestar fede all’altra leggenda che dovette abbandonare la città per la persecuzione di un nobile nella cui tenuta aveva rubato un daino, presumibilmente per sfamare tanta gente… Fatto sta che nel 1592 William, che forse già aveva composto qualcosetta per compagnie provinciali, piantò baracca e burattini per andare a sbarcare il lunario a Londra, contando sulle sue doti, ancora tutte da dimostrare, di attore e drammaturgo.

Presto divenuto amico del conte di Southampton, William se lo ingraziò con due modesti ma lascivi poemi narrativi, Venere e Adone e Lucrezia, esordendo intanto sulla scena con Enrico VI, di maniera ancora incerta, ma già recante alcuni tratti sentimentali e comici che poi gli saranno congeniali. Accanto al genere storico, nel quale sfornerà ben più complessi capolavori, Shakespeare (che come attore sembra essere stato piuttosto mediocre), non mancò di cimentarsi negli anni seguenti col genere plautino (La commedia degli equivoci) e col dramma degli orrori di ispirazione senechiana (Tito Andronico), dove ancora evidente risulta l’influsso di Marlowe. Ma comunque lanciato in carriera, dovette interromperla per la chiusura dei teatri causata dalla peste. E fu forse per sfuggire all’epidemia che fece un soggiorno nella nostra penisola, che dovette rivelarsi fruttuoso di idee e conoscenze, visto che al ritorno produsse tutta una serie di lavori d’ambientazione italiana e pieni di arguzia e galanterie (La bisbetica domata, I due gentiluomini di Verona, Pene d’amor perdute), e soprattutto Romeo e Giulietta, dove invece velò di pietà il tragico destino dei due giovinetti vittime dei pregiudizi sociali e della beffa del fato.
Negli anni seguenti, dominando ormai incontrastato le scene inglesi, Shakespeare si diede al dramma storico (Riccardo II, Re Giovanni, Enrico IV, che ospita l’immortale figura di Falstaff, quintessenza di vizi carnali e di gola, beone e millantatore poi scornato ne Le allegre comari di Windsor); e produsse alcune brillanti commedie gradite al pubblico di allora e di oggi per la compiuta commistione di serio e faceto, travestimenti e dramma, riso e pianto (Sogno di una notte di mezza estate, Il mercante di Venezia, Molto rumore per nulla, Come vi piace, La notte dell’Epifania). Ma intanto affilava le unghie per la grande sfida con la tragedia, genere in cui, malgrado il truce carattere del Riccardo III, non aveva ancora dato piena misura del suo genio. Il proposito di trasformare la fosca ricetta antica della vendetta è realizzato nel personaggio di Bruto del Giulio Cesare, e soprattutto nell’Amleto: capolavoro assoluto per l’appassionata protesta contro i sofismi del pensiero, che smarrendosi tra essere e non essere gettano un velo di apparenza sulla realtà, sottraendole ogni certezza…
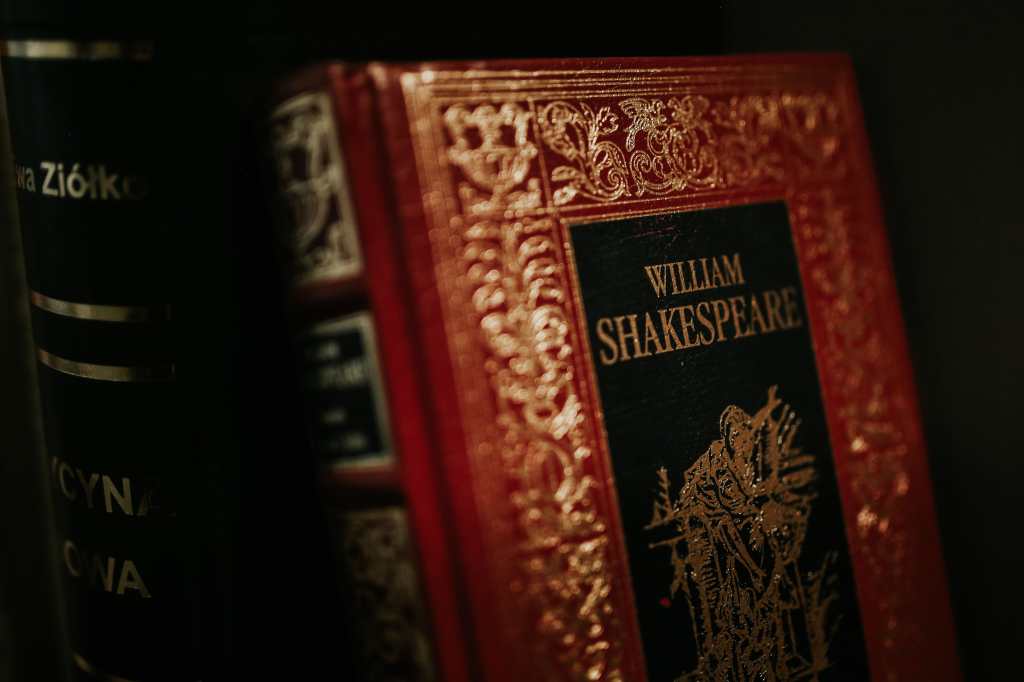
Non sappiamo se altre vicende dolorose seguirono la morte del figlio Hamnet nel 1596, ma di certo le creazioni successive tradiscono venature di disincanto, delusione e amarezza, e rivelano uno spirito turbato da profondo pessimismo e un ossessivo senso di catastrofe (Troilo e Cressida, Tutto è bene quel che finisce bene, Misura per misura), pur lasciando posto a qualche conflittuale ambiguità. Ambiguità che però svanisce del tutto nelle grandi tragedie delle passioni devastanti, come la funesta gelosia di Otello, l’irriconoscenza che spezza Re Lear, o l’ambizione che travolge Macbeth: che studiano da versanti diversi l’ineluttabilità del male in una vita intesa come “favola raccontata da un idiota, piena di rumore e furore, che non significa nulla”. Appena sottrarsi a questo vortice di passioni sembrerebbe il disincanto di Antonio e Cleopatra, che vanno incontro alla rovina come amanti antitetici in un alone romantico. Contrasto che ritorna ancora tra l’orgoglio di Coriolano e l’opportunismo della madre; mentre il Timone d’Atene rinnova in un gioco di maschere l’amara satira dell’ingratitudine che era stato il tormento di Lear…
Dopodiché, gli ultimi drammi si svolgono in un clima di serenità, appena contestata dalle parole finali di Prospero nella Tempesta: “And my ending is despair”. Fatto sta che nel 1610 Shakespeare si ritirò a Stratford, per trascorrervi gli ultimi anni, che, malgrado qualche dispiacere causatogli dalle figlie Susanna e Judith, dovettero essere nel complesso riposanti. E qui morì, secondo un’intrigante tradizione, in seguito a una gigantesca sbevazzata in compagnia di Ben Johnson e Drayton. La sua salute del resto doveva essere già da tempo malferma, visto che solo un mese prima aveva stilato il testamento in cui, peraltro, ignorando l’opera, sembrò occuparsi solo del suo destino di uomo: “confido la mia anima a Dio e (…) rimetto il mio corpo alla terra di cui è fatto.”
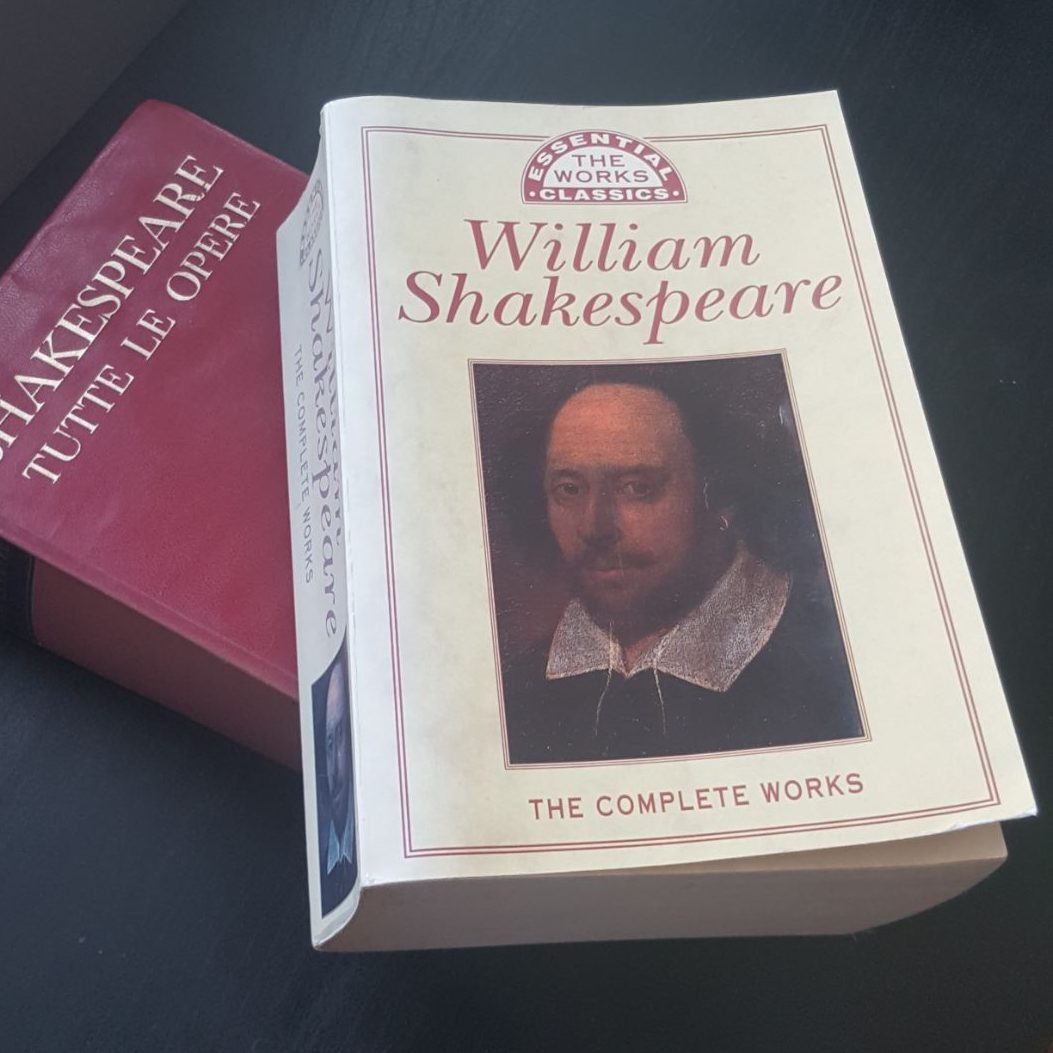
Nondimeno l’opera restava, esclamativa, malgrado le pubblicazioni selvagge e abusive, tra tagli, sommari, aggiunte e rattoppamenti, che dicono comunque il bisogno di riudirne la parola. E pretestuosi sembrano i tentativi di chi, non digerendo che tanto ingegno potesse albergare nella cervice di un attorucolo di provincia, volle farne un mero prestanome di ingegni più titolati, compreso Bacone. Altrettanto ridicole suonano le accuse mosse da qualche pruriginoso ai Sonetti (che da soli ne decreterebbero la gloria, se l’autore non avesse avuto in serbo altre cartucce…), o ai due poemetti licenziosi… Più seriamente invece va accolta certa critica ai debordamenti estetici, a certo gusto per i calembours e gli artifizi baroccheggianti. Il fatto è che Shakespeare era restio a ritornare sui propri testi, che con una revisione accurata avrebbe potuto epurare di ripetizioni, esagerazioni e lungaggini. Un po’ ce ne dispiace, invero. Ma che farci? Si può forse chiedere a un vulcano di eruttare di meno?

Abbonati a Giornate di lettura
Unisciti gratuitamente a centinaia di nostri abbonati e abbonate, e sii il primo a ricevere nuovi contenuti.


grazie!!!
"Mi piace"Piace a 1 persona
[…] William Shakespeare: un barbaro non privo di ingegno […]
"Mi piace""Mi piace"
[…] destino di nascere e morire nello stesso giorno che toccò a William Shakespeare fu anche quello di Kostantinos Kavafis, nato ad Alessandria d’Egitto il 29 aprile del 1863 ed ivi […]
"Mi piace""Mi piace"
[…] poiché consente di interrompere la lettura in qualsiasi momento, vi consiglio Misura per misura di William Shakespeare. Si tratta di un’opera che, pur appartenendo alla grande stagione creativa che da Amleto conduce […]
"Mi piace""Mi piace"