
Perché ci attraggono le foto di guerra? Social media, giornali e riviste ci bombardano di immagini dai vari fronti caldi del mondo sin dal XIX secolo: sono i ritratti più crudi dalla violenza umana, che immaginiamo ripresi mentre si riversa su una vittima di solito inerme.
Perché la morte esercita su di noi un tale fascino? Serve a qualcosa ritrarla? Quand’è che la denuncia si trasforma in voyeurismo? A tali e altre domande sulla professione di reporter sul campo risponde Susan Sontag nel suo Davanti al dolore degli altri. Per me, è stata la prima opera di Sontag consigliata in un paio di occasioni da Marta Ciccolari Micaldi (@la_macmusa), americanista molto attiva online, e da Marina di @io_amo_leggere_e_tu, profilo Instagram e Facebook ricco di interessanti proposte di letture!
Ma torniamo a noi. Per chi non la conosce, Susan Sontag è stata una figura di spicco del mondo intellettuale statunitense, dotata di acuto spirito critico (come emerge anche in questo lavoro), grazie al quale ha saputo scrivere saggi sull’arte, sulla politica e sulla società americana del suo tempo. Nata il 16 gennaio 1933, è stata autrice di romanzi (di successo fu L’amante del vulcano, del 1992), critica e attivista. Apertamente bisessuale, ha contribuito al dibattito intorno ai diritti civili della comunità LBTQIA+ e alla libertà di espressione, influenzando con i suoi scritti ambiti che vanno dal cinema al teatro, dalla letteratura alla critica culturale più in generale.
In Davanti al dolore degli altri Susan Sontag avvia la sua disamina del ruolo della fotografia di guerra facendo riferimento ad un’opera meno conosciuta di Virginia Woolf, Le tre ghinee, del 1938. Nel pamphlet Woolf si sofferma su alcune immagini agghiaccianti giuntele come testimonianza della guerra civile spagnola, sostenendo che dovrebbero da sole bastare per convincere chiunque dell’inutilità della guerra. Tuttavia, Sontag non è d’accordo e introduce fin dal primo capitolo un concetto che diventa il filo conduttore del suo testo: le foto non possono essere considerate come una riproduzione fedele e oggettiva della realtà. Questo è il motivo per cui esse non sono sufficienti a dimostrare l’insensatezza dei conflitti tra gruppi: ciò che per qualcuno è un’atrocità, strumento di denuncia, può essere per altri un invito a non arretrare. Inoltre, anche la didascalia, rivelando l’identità del soggetto che soffre, modifica la nostra percezione del dolore patito. Nonostante la fotografia sia concepita come uno dei mezzi più immediati e veritieri, essa non rivela la stessa realtà a ognuno di noi.
Varia, ossia, l’intensità ma anche la natura delle emozioni suscitate nell’osservatore, a seconda della sua identità individuale o nazionale, a seconda, in altre parole, della sua storia. Se alcuni, posti davanti alle immagini di un massacro, invocano il ritorno della pace, altri sentono rinvigorirsi il desiderio di vendetta, la necessità di riscattare con altro sangue le vittime innocenti. Così accade anche nella nostra quotidianità: quanti di noi, guardando le stragi delle bombe sugli ospedali di Gaza, hanno sperato in una più celere opera diplomatica? Quanti altri hanno allentato le briglia della civiltà, galvanizzati da inopportuni rigurgiti di antisemitismo?
Il fascino per la morte non nasce certo con l’avvento della fotografia, basti pensare alle rappresentazioni che se ne ritrovano in pittura. Da un rapido confronto tra queste due forme di arte visiva, emerge come ancora oggi la prima ci dia l’illusione di essere più partecipi dell’evento rappresentato, seppur questo si snodi in zone lontanissime da noi: un effetto di mimesi che la pittura può difficilmente raggiungere. La morte catturata dalla macchina sembra immortalata nel suo accadere; al contempo, fa da controcanto a questa apparente neutralità, la soggettività dell’inquadratura, scelta dal fotografo, che può decidere di dare risalto ad uno o un altro aspetto. Ed è proprio su questa commistione di verità e sentimento che crolla l’ideale di oggettività della fotografia.
Come detto, la stessa immagine può suscitare reazioni opposte e pertanto portare avanti istanze divergenti. Si pensi all’Ucraina: per quanto giustificato sia un conflitto, la popolazione, un tempo pronta a dare convinto supporto alle azioni belliche, si sentirà sopraffatta e stanca, e finirà per trasformare le ovazioni di libertà in frustrate critiche. In un contesto come questo, le immagini di scuole distrutte, di bambini trucidati, di soldati macellati possono spingere le proteste e acuire la convinzione. D’altro canto, scrive Sontag:
«la stessa fotografia contro la guerra può essere letta come un’immagine che mostra il pathos, o l’eroismo, l’ammirabile eroismo, di una lotta inevitabile che può concludersi soltanto con la vittoria o la sconfitta. Le intenzioni del fotografo non determinano il significato della fotografia, che avrà vita propria, sostenuta dalle fantasie e dalle convinzioni delle varie comunità che se ne serviranno».
In tutto il saggio, scritto peraltro con una lingua curata e sentita, che non cade mai in facile retorica, Sontag sottolinea più volte la natura soggettiva e non scientifica della fotografia, ripercorrendo la storia di un’arte caratterizzata dalla contraffazione:
«La cosa strana non è il fatto che molte delle fotografie più emblematiche del passato, incluse alcune delle più note immagini della Seconda Guerra Mondiale, siano una montatura. La cosa strana è che siamo sorpresi di scoprirlo, e ne restiamo sempre delusi».
Va detto che quello di Sontag non è un attacco deliberato alla pubblicazione di immagini di guerra, quanto piuttosto un’acuta analisi del suo prezzo morale. Se da un lato osservare la sofferenza degli altri può renderci più partecipi, dall’altro bisogna chiedersi dove porre il limite oltre il quale il rispetto per il corpo delle vittime dovrebbe frenare la diffusione di una fotografia. Un pensiero questo quanto mai pressante nel nostro mondo digitale, governato dall’algoritmo e dal numero dei click, che spinge a pubblicare contenuti sempre più scioccanti con il rischio concreto che l’osservatore si abitui anche al peggio.
Lo stile argomentativo di Sontag è preciso, e non manca di descrivere con perizia alcune celebri fotografie, oltre che gli incredibili retroscena che ne hanno contraddistinto lo scatto. Tra gli spunti che mi hanno più colpita c’è senz’altro la riflessione sul legame tra fotografia e informazione: la prima, per quanto di impatto, non può spiegarci da cosa nasce la violenza davanti alla quale ci troviamo; può stupirci, ma non può aiutarci a comprendere il quadro generale della vicenda. Eppure talvolta questo sembra bastarci, poiché quella fiammella di sdegno, insiste Sontag, ci pulisce la coscienza, ci permette di sfogliare (o scrollare) oltre, senza sentirci troppo in colpa della nostra ignoranza. Al contrario,
«sarebbe meglio mettere da parte la compassione che accordiamo alle vittime della guerra e di politiche criminali per riflettere su come i nostri privilegi si collocano sulla carta geografica delle loro sofferenze e possono – in modi che preferiremmo non immaginare – essere connessi a tali sofferenze, dal momento che la ricchezza di alcuni può implicare l’indigenza di altri. Ma per un compito del genere le immagini dolorose e commoventi possono soltanto fornire una scintilla iniziale».
Davanti al dolore degli altri è un testo lucidissimo, che oggi ha assunto un’attualità maggiore che che all’epoca della sua publicazione. È un saggio che aiuta a muoversi con maggior consapevolezza in un mondo mediatico sempre più pieno e cruento, invitando a una comprensione più critica dei fenomeni che vada oltre le immagini a effetto.

Entra a far parte della community
Unisciti gratuitamente a centinaia di nostri abbonati e abbonate, e sii il primo a conoscere nuovi contenuti.

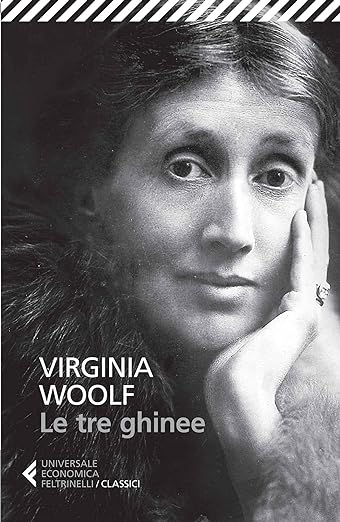

[…] “Davanti al dolore degli altri”: Susan Sontag e i limiti della fotografia di guerra […]
"Mi piace""Mi piace"
[…] ✍️ RECENSIONE => “Davanti al dolore degli altri”: Susan Sontag e i limiti della fotografia di guerra […]
"Mi piace""Mi piace"